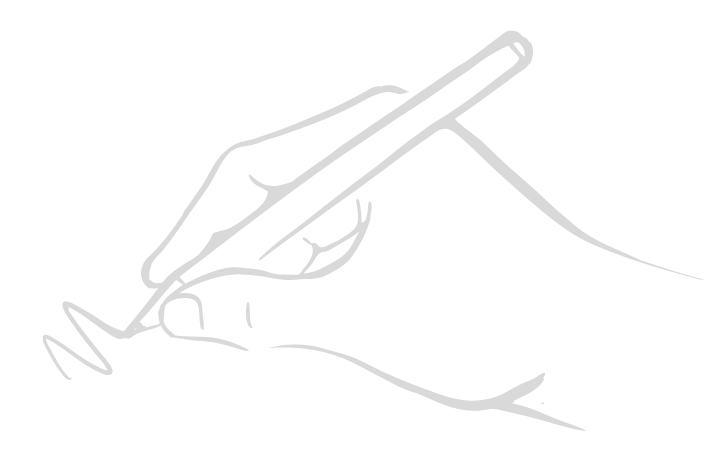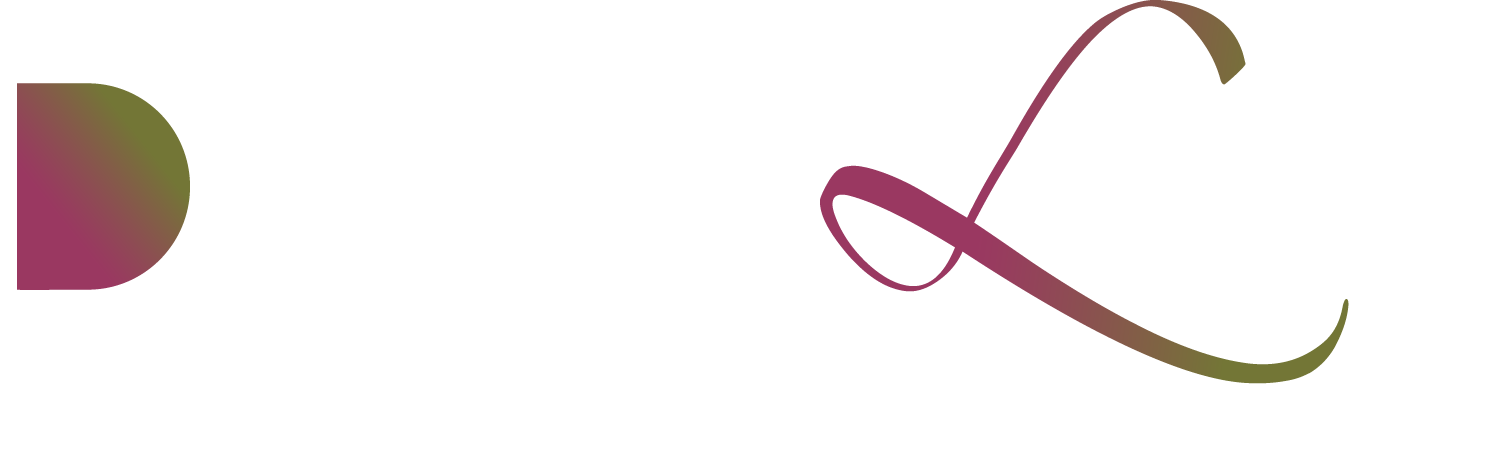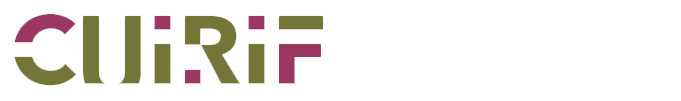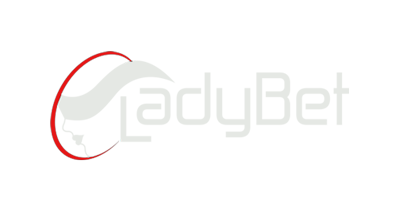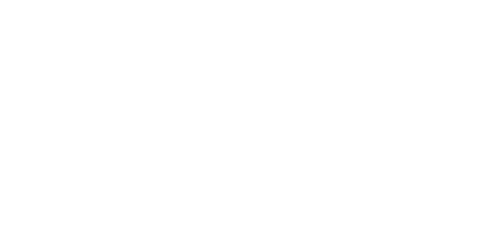Abstract
Il contributo analizza il tema della qualità nella produzione e gestione dei metadati dedicati alla gestione documentale. L’analisi è incentrata sul raffronto tra l’approccio di base che si ritrova nelle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico emanate da AgID e l’approccio adottato, invece, dal principale standard internazionale in tema di metadati per il records management, l’ISO 23081-1.
“Uno, nessuno, centomila” metadati
Probabilmente, uno dei terreni più scivolosi che stiamo attraversando, nell’odierno passaggio dal tradizionale scenario analogico al nuovo scenario digitale, è quello popolato dai metadati. Citatissimi, tanto da essere menzionati in qualsivoglia progetto di digital transformation che voglia essere degno di questa qualifica, i metadati sono, però, ammantati di ambiguità quanto alla loro produzione ed uso. Tanto che anche la loro definizione più consueta – dati relativi ad altri dati – si risolve in una tautologia che poco o nulla chiarisce della loro natura e finalità e, dunque, del perché essi svolgano un ruolo essenziale nei processi di trasformazione digitale.
Tali incertezze, combinate con un utilizzo inflazionato del termine, mi fanno a volte pensare al concetto di metadati come a una nozione che dal nostro uso, poco consapevole, viene svuotata del suo significato più profondo. Le ragioni di questo stato di cose sono diverse. Tra quelle che riesco a intravedere, senz’altro il fatto che nel precedente scenario analogico noi tutti facevamo un uso per lo più intuitivo dei metadati, utilizzandoli senza quasi renderci conto che li maneggiassimo con frequenza: pensiamo agli schedari dei vecchi cataloghi di biblioteca o ai timbri, alle sigle e alle altre diciture manoscritte – in generale a quelle che tecnicamente sono delle annotazioni – che apponevamo al documento originale su supporto cartaceo, ogniqualvolta eravamo chiamati a servircene per svolgere, ad esempio, delle attività d’ufficio.
Un’altra ragione, che forse spiega le ambiguità e incertezze che stiamo osservando, si ritrova nel fatto che il passaggio allo scenario digitale ha enormemente ampliato il ricorso ai metadati, tanto che oggi le finalità che li chiamano in campo sono non solo numerose, ma tra loro anche assai diversificate: per descrivere e indicizzare gli oggetti digitali, così da facilitare la loro ricerca e recupero da parte di utenti che si servono di piattaforme di diversa natura; per corredare le pagine web e rendere possibile il loro pertinente recupero da parte dei motori di ricerca; per definire e rendere conoscibili i diritti di accesso e d’utilizzo delle risorse digitali messe a disposizione di possibili fruitori; per tracciare, con delle evidenze, i processi e le interazioni che avvengono all’interno dei sistemi informativi in uso alle organizzazioni; ancora, per annotare (marcare) le informazioni o corredare gli oggetti digitali che oggi sono scambiati tra diverse applicazioni, così da abilitare l’interoperabilità semantica di queste ultime e salvaguardare l’autenticità degli stessi digital object. E questo primo elenco, puramente indicativo, potrebbe estendersi ulteriormente.
Naturalmente ciascuna finalità d’uso si accompagna a una specifica logica di individuazione dei metadati necessari a soddisfare lo scopo prefissato. Si generano, allora, ambiguità e incertezze: da un contesto d’utilizzo all’altro i set di metadati richiesti possono differenziarsi di molto e allora, se non si dominano le logiche d’individuazione che a loro volta rimandano alle differenti finalità specifiche, si ha quasi l’impressione di stare al centro di una galassia polverizzata, nella cui vastità si perde il senso di ciascun metadato e, alla fine, ci si trova smarriti dinnanzi al nulla. In una sorta di rivisitazione digitale della lezione impartita dal romanzo di Luigi Pirandello “Uno, nessuno, centomila”.
Nel contenere e governare queste incertezze e ambiguità, certo sono d’aiuto gli standard e i relativi profili applicativi che, negli anni, hanno conosciuto una rapida proliferazione proprio nel campo della produzione e gestione dei metadati. Essi, però, non risolvono interamente il problema: ogni standard e profilo applicativo, per quanto dettagliato nella sua formalizzazione, comporta una dose di flessibilità per la sua corretta attuazione. Ed allora, attraverso quella stessa flessibilità ritorniamo, in qualche modo, alle criticità di partenza: flessibilità di impiego significa, infatti, apertura a possibili declinazioni affidate alla responsabilità di coloro che scelgono di affidarsi allo stesso standard o profilo applicativo. Per quanto riguarda i metadati, siamo soliti, dunque, partire dalla domanda su “quali e quanti metadati produrre e gestire”, ma, più correttamente, dovremmo forse partire dall’interrogativo preliminare sul “perché produrre e gestire dei metadati” in rapporto a un certo dominio digitale. In fondo, solo impostando con la giusta sequenza gli interrogativi del caso abbiamo l’opportunità di garantire la qualità dei metadati come corredi informativi capaci di soddisfare, in modo efficace e sostenibile, gli scopi che ci hanno spinto alla loro produzione e gestione.
I metadati per la gestione documentale
Uno dei contesti in cui, oggi, risulta più intensivo l’uso dei metadati è quello della gestione documentale: l’ambito che abbraccia la produzione, gestione e mantenimento nel tempo dei documenti che formano quegli archivi digitali correnti, di cui le organizzazioni – tanto pubbliche quanto private – si servono, per lo svolgimento delle proprie attività e che, pertanto, le stesse considerano come degli asset informativi strategici.
Questo peculiare contesto d’utilizzo è un esempio, in qualche modo paradigmatico, delle incertezze e ambiguità che investono, più in generale, il ricorso ai metadati nel dominio della trasformazione digitale. Ce ne rendiamo subito conto se analizziamo, con sguardo critico, le regole tecniche che oggi normano la gestione documentale e che, come è noto, sono raccolte nelle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici[1]. Si tratta di un corpus regolatorio di grande rilievo, anche perché, secondo quanto disposto dal Codice dell’amministrazione digitale, quelle stesse regole tecniche si applicano non solo alle amministrazioni pubbliche, ma anche ai gestori di pubblici servizi, alle società a controllo pubblico e alle organizzazioni private[2], dunque a molta parte delle dimensioni sociali che popolano la nostra quotidianità. Ebbene, nel contesto di tali regole tecniche, i metadati sono puntualmente disciplinati. Infatti, l’estensore delle Linee guida non solo ha avvertito la necessità di dedicare uno specifico allegato alla loro esatta individuazione[3], ma ha previsto per essi dei requisiti di grande rilievo: “al momento della formazione del documento informatico immodificabile, devono essere generati e associati permanentemente ad esso i relativi metadati. L’insieme dei metadati del documento informatico è definito nell’allegato 5 […] alle presenti Linee guida[4]”.
Dal che i metadati, nel loro essere permanentemente associati al documento digitale, emergono non come un elemento transeunte e tutto sommato contingente dello stesso, ma piuttosto come una sua dimensione essenziale, che deve persistere per tutto il tempo in cui il documento stesso è usato. Al punto che ci si potrebbe spingere ad affermare che non si dà, realmente, un documento digitale se i file che compongono il suo contenuto non sono al contempo corredati da metadati, quasi che quest’ultimi fossero l’elemento dirimente per distinguere cioè che noi spesso erroneamente confondiamo: il file da un lato e il documento digitale dall’altro, come surrogato autorevole di una porzione di realtà.
Ed ancora, secondo le Linee Guida “la pubblica amministrazione documenta la propria attività tramite funzioni del sistema di gestione […] dei documenti finalizzate alla produzione, alla gestione e all’uso delle aggregazioni documentali informatiche, corredate da opportuni metadati, così come definiti nell’allegato 5 […] alle presenti Linee guida[5]”.
Indicazione, questa, che chiaramente evidenzia come i metadati siano una dimensione non solo essenziale, ma anche pervasiva. Essa, infatti, investe non solo le singole occorrenze documentali, ma persino le loro aggregazioni e, prima fra tutte, il fascicolo informatico: in una sorta di movimento a spirale, in ragione del quale il documento digitale nella sua dinamica aggregativa trascina con sé quell’elemento imprescindibile rappresentato dai metadati. Tanto che, allora, la logica di individuazione dei metadati deve declinarsi secondo una chiave gerarchica, dunque su diversi livelli di granularità. A conferma di questo legame così cogente, tra documentazione e metadati, le Linee guida prescrivono che nel principale strumento per la definizione trasparente delle policy dedicate agli archivi digitali, il manuale di gestione documentale, la singola organizzazione debba puntualmente dar conto dei set di metadati definiti per ogni tipologia di documento utilizzata [6].
A dispetto del riconoscimento di requisiti tanto significativi, sorprende però una circostanza: le regole tecniche non si preoccupano mai di contestualizzare quegli stessi requisiti alla luce di una definizione della finalità di fondo che i metadati sono chiamati ad assolvere nell’economia della gestione documentale.
Evidenziato, in altri termini, che i metadati sono una componente essenziale del documento digitale e delle sue aggregazioni, qual è nondimeno lo scopo specifico che essi realizzano e che dà conto di quella relazione tanto stringente? A questo interrogativo basilare le Linee guida non danno alcuna risposta. E non si tratta, in realtà, di una domanda di natura puramente speculativa, che qualcuno potrebbe ritenere poco idonea a figurare in un corpus di regole tecniche. Come si è visto, infatti, in tutti i contesti di utilizzo dei metadati la consapevolezza sulla loro peculiare finalità d’impiego permette, al contempo, una loro efficace individuazione e una loro sostenibile gestione. E allora ci dobbiamo attendere che la non applicazione al dominio del records management di tale criterio dovrà pur generare un qualche tipo di conseguenza non auspicabile.
Seguendo questa linea interpretativa, possiamo ritenere che la circostanza per cui le Linee guida, nel regolamentare i metadati, non partano dalla preliminare esplicitazione della finalità specifica che essi svolgono nel contesto della gestione documentale, abbia generato delle criticità nella loro logica di individuazione. E infatti, a uno sguardo accorto, il set di metadati minimi previsto in uno degli allegati che compongono le Linee guida[7] appare come caratterizzato da una rigidità eccessiva: quasi un monolite, che dovrebbe essere applicato tanto dalle organizzazioni private quanto da quelle pubbliche e, tra quest’ultime, tanto da quelle statali quanto da quelle locali, tanto da quelle che svolgono prevalentemente compiti amministrativi quanto da quelle che si dedicano, per lo più, ad attività tecniche. Una rigidità dovuta al fatto che il set di metadati formalizzato non discende, per l’appunto, dalla preliminare definizione dello scopo a cui essi sono chiamati nell’ambito della gestione documentale, ma è sostanzialmente dedotto da un modello puntuale[8], seppur autorevole: quello rappresentato dalla tradizionale registrazione di protocollo delle scritture in entrata e in uscita e che corrisponde solo a un sottoinsieme – più o meno ristretto – dei documenti realmente utilizzati dalle diverse organizzazioni.
L’imperativo etico per la qualità dei metadati di gestione documentale
Per una trasformazione digitale che mantenga davvero tutte le promesse attese è necessario, tra l’altro, che le nostre organizzazioni si orientino verso una gestione documentale avanzata: capace, dunque, non solo di includere la dimensione della produzione e gestione di metadati – ahimé talvolta depotenziata da una logica di mero adempimento formale alle norme – ma soprattutto di far perno nel merito su metadati di qualità, superando al contempo le criticità osservate per le Linee guida.
Una chiara direzione, in vista di questo imperativo della qualità, è offerta dal principale standard in tema di metadati per la gestione documentale: l’ISO 23081-1:2017[9]. Come nel caso delle regole tecniche cui si è sopra accennato, anche questo strumento di normazione tecnica volontaria riconosce, naturalmente, che i metadati sono una dimensione davvero imprescindibile nella gestione del ciclo di vita degli archivi digitali correnti: “metadata management is an inextricable part of record management, serving a variety of functions and purposes”[10]. Si va però ben oltre l’affermazione di una stretta relazione, perché questa è qualificata quasi nei termini di un rapporto di “rispecchiamento”: “management of metadata entails the same processes as described in ISO 15489-1:2016 […] [that is] creation, capture, storage, description, maintenance, access, definition of policies, strategies and methods”[11].
La citazione di ISO 15489-1:2016 deve leggersi qui come il riferimento al principale standard dedicato alla gestione dei documenti. A dispetto della sua concisione, questo passaggio evidenza un principio di grande rilievo: quello per cui la gestione documentale ha un suo “doppio”, rappresentato dalla gestione dei metadati.
Pertanto se i documenti sono apparati con cui surrogare – documentare – nel tempo e nello spazio delle porzioni di realtà, i metadati sono altrettanti apparati con cui documentare quegli stessi documenti[12].
Quasi un gioco di specchi, confermato dal fatto che, nella prospettiva dello standard, i metadati affrontano quella stessa criticità che è sempre una sfida aperta per il documento soprattutto se digitale, la sfida dell’autenticità[13]: “records management metadata are as much subject to authenticity rules or criteria as the records to which they are linked in order to make them trustworthy[14]”.
A partire da questo rapporto di “rispecchiamento”, si può apprezzare la profonda diversità di approccio dello standard rispetto alle nostre regole tecniche, a dispetto del fatto che quest’ultime includono proprio l’ISO 23081-1 nell’elenco degli strumenti che possono considerarsi come coerenti con le Linee guida[15]. Ed allora si dovrà, probabilmente, considerare tale coerenza solo come parziale.
I redattori dello standard chiariscono, infatti, per quale ragione i metadati debbano considerarsi un “doppio del documento”, quella sorta di specchio in cui il documento stesso si documenta. E nel far ciò dichiarano, con tutta evidenza, la finalità che i metadati devono assolvere, nel contesto del ciclo di vita degli archivi digitali correnti. Tanto che tutti i principi guida contenuti in ISO 23081-1 devono considerarsi come il risultato di una deduzione – questa volta sì veramente coerente – dall’affermazione preliminare di quella stessa finalità fondamentale: “records management has always involved the management of metadata. However, the digital environment requires a different expression of traditional requirements and different mechanisms for identifying, capturing, attributing and using metadata. In the digital environment, authoritative records are those accompanied by metadata defining their critical characteristics. These characteristics must be explicitly documented rather than being implicit, as in some paper-based processes”[16].
I metadati allora, in questo loro essere uno strumento per esplicitare – documentare – le caratteristiche cruciali dei documenti che vivono all’interno dei sistemi di gestione documentale, rivelano due aspetti di cui non siamo sempre così consapevoli. In primo luogo i metadati appaiono come una delle espressioni più tipiche del nuovo scenario tecnologico.
Infatti “anche per il ricorso al digitale vi è […] un prezzo da pagare […] Se lo scenario analogico basava molta parte della propria operatività su un patrimonio di conoscenze implicite, l’orizzonte digitale esige al contrario di comprimere quanto più possibile quello stesso patrimonio, in vista della necessità di trasformarlo in conoscenza esplicita. Questo faticoso sforzo di traduzione è, a sua volta, legato al fatto che le tecnologie emergenti risultano assai poco indulgenti: esse, infatti, non tollerano soluzioni contingenti e accidentali o anche solo improvvisate e impreviste, ma richiedono la preliminare […] esplicitazione di scenari rigorosamente modellati e per questo capaci di fornire risorse attendibili in termini di predizione dei comportamenti funzionali e dei requisiti d’operatività”[17].
Dunque, nel loro farsi carico della traduzione, da “implicito a esplicito”, delle caratteristiche fondamentali di documenti digitali che vogliono essere credibili – gli authoritative records di cui al paragrafo sopra citato di ISO 23081-1 – i metadati si rivelano come una tipica manifestazione dello scenario digitale.
E in questa loro veste essi palesano un secondo aspetto di cui non sempre abbiamo sufficiente consapevolezza: il fungere da potente strumento di contrasto alle logiche auto-referenziali, che minacciano la dimensione della gestione documentale, soprattutto se digitale. L’azione dell’esplicitare – documentare – tramite i metadati significa, infatti, permettere al documento digitale, nei suoi movimenti nello spazio e nel tempo potenzialmente incessanti, di essere realmente usato al di fuori degli originari ambiti in cui è stato inizialmente prodotto[18]. Infatti, un adeguato corredo di metadati abilita l’entità documentale ad essere:
- intellegibile a partire da informazioni di contesto che non sono più legate solo all’implicita conoscenza incorporata nella memoria individuale o collettiva di coloro che hanno inizialmente prodotto il documento stesso;
- comprensibile a partire da informazioni di contesto che esplicitano le attività che hanno presieduto all’originaria produzione del documento stesso e che altrimenti potrebbero presentarsi come criptiche per tutti coloro che non coincidono con il suo iniziale produttore;
- utilizzabile anche nel medio e lungo termine da una platea di soggetti che si susseguono nel tempo, attraverso informazioni di contesto che esplicitano i fattori critici per la sostenibilità del documento stesso, a prescindere dal lasso di tempo in cui questo è usato dall’originario produttore.
In tale prospettiva, una produzione e gestione di metadati che sia davvero rispondente alle finalità di documentazione – che sono poi delle finalità legate all’esplicitazione dei contesti del documento e al contrasto delle logiche auto-referenziali messe in atto dai suoi originari produttori – si riveste di un imperativo di natura etica: garantire l’usabilità del documento, senza soluzione di continuità lungo il suo intero ciclo di vita, a favore di tutti coloro che saranno destinati a imbattersi nel documento stesso e a prescindere dagli originari scopi che avranno dettato la sua venuta al mondo.
Così ISO 23081-1 si incammina su un percorso che, in prima battuta, potrà sorprenderci: quello di non definire alcun set in senso stretto di metadati per la gestione documentale. Certo una differenza – l’ennesima – di non poco conto rispetto a quelle Linee guida che pure pretenderebbero di ispirarsi a tale strumento di normazione volontaria. Se, infatti, la finalità dei metadati in rapporto al ciclo di vita degli archivi digitali correnti è quella fin qui descritta, allora essi riusciranno a soddisfarla in modo efficace e sostenibile e dunque con una soluzione di qualità, solo qualora ogni organizzazione sia in grado di individuare autonomamente il set di metadati più rispondenti al proprio peculiare contesto di gestione documentale e al proprio caratteristico dominio documentale. E, rispetto a questa prospettiva, lo standard garantisce un preciso spazio operativo: fornire i principi, i concetti, i modelli e gli strumenti essenziali con cui ciascuna organizzazione possa dotarsi di una logica d’individuazione dei metadati coerente con la loro finalità dichiarata, per evitare così che la rigidità di set predefiniti e riproposti su vasta scala impoverisca la capacità dei metadati stessi di dare risposte ai compiti cruciali sopra ricordati e a cui essi sono chiamati in rapporto alle dinamiche documentali digitali.
NOTE
* Gli indirizzi web citati sono stati consultati in data 3 agosto 2025.
[1] Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, approvate dall’Agenzia per l’Italia digitale con determinazioni del direttore generale 9 settembre 2020, n. 407 e 17 maggio 2021, n. 371.
[2] Art. 2, commi 2 e 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
[3] Allegato 5 al documento “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”.
[4] Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, cit., p. 13.
[5] Ivi, p. 22.
[6] Ivi, p. 13.
[7] Vedi nota 3.
[8] Già nel 1996 Angelo Spaggiari segnalava una criticità dei modelli di gestione documentale attestati nel nostro paese e “imputabile all’eccessivo peso attribuito al sistema protocollo […], che ben si addice a modelli archivistici corrispondenti alle ‘funzioni di amministrazione generale’, ma che è addirittura inapplicabile a vari altri modelli corrispondenti ad altre funzioni” (Angelo Spaggiari, Giuridicità, archivistica e storicità degli archivi pubblici nell’Italia postunitaria, Modena, Mucchi, 1996, p. 21).
[9] International Organization for Standardization, International standard ISO 23081-1. Information and documentation – Records management processes – Metadata for records – Part 1: Principles, [Geneva], ISO, 20172.
[10] Ivi, cap. 4, p. 2. Il corsivo è di chi scrive.
[11] Ivi, cap. 8.4.1, p. 8.
[12] Alessandro Alfier, Documentare con i metadati il documento digitale, Milano, «Annuario dell’Archivio di Stato di Milano», 2020, pp. 28-40.
[13] Alessandro Alfier, Fiducia e documento: il rompicapo dell’autenticità, «Digeat», 3/2024; Francesco Del Castillo, Fiducia e documento: innovazione e tradizione nello scenario digital, «Digeat», 3/2024; Alessandro Alfier e Francesco Del Castillo, Il documento e la fiducia, e-book, Edizioni Digitalaw, Lecce, 2025.
[14] International Organization for Standardization, International standard ISO 23081-1, cit., cap. 8.4.10.2, p. 10.
[15] Standard e specifiche tecniche. Allegato 4 al documento “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”.
[16] International Organization for Standardization, International standard ISO 23081-1, cit., cap. 4, p. 3.
[17] Alessandro Alfier, La natura poco indulgente del digitale e il rapporto con le discipline umanistiche, in Paola Ciandrini (a cura di), Umanesimo digitale. Percorsi e contaminazioni disciplinari, Milano, Editrice bibliografica, 2023, p. 71-85, in particolare p. 74.
[18] International Organization for Standardization, International standard ISO 23081-1, cit., cap. 5.2.1, p. 4.
PAROLE CHIAVE: gestione documentale / ISO 23081 / Linee guida di AgiD / metadati
Tutti i contenuti presenti in questa rivista sono riservati. La riproduzione è vietata salvo esplicita richiesta e approvazione da parte dell’editore Digitalaw Srl.
Le foto sono di proprietà di Marcello Moscara e sono coperte dal diritto d’autore.