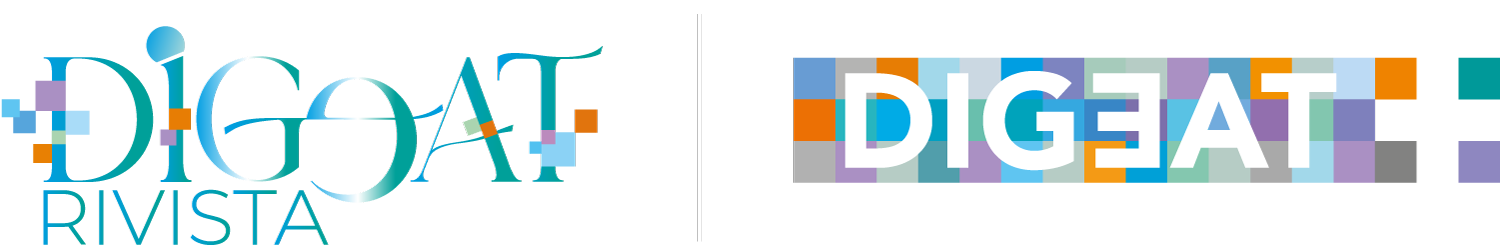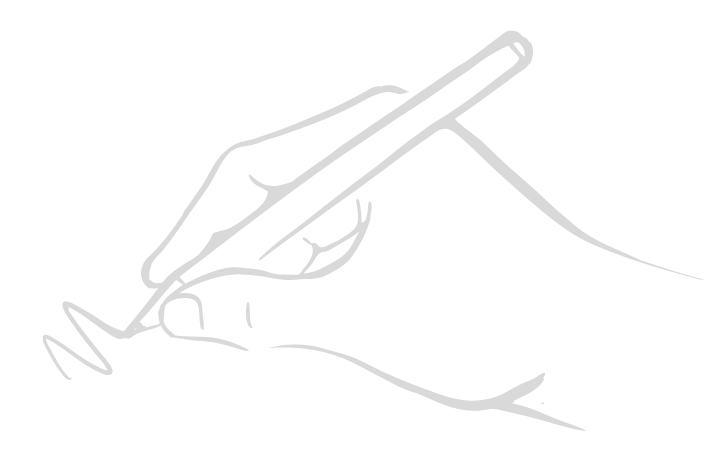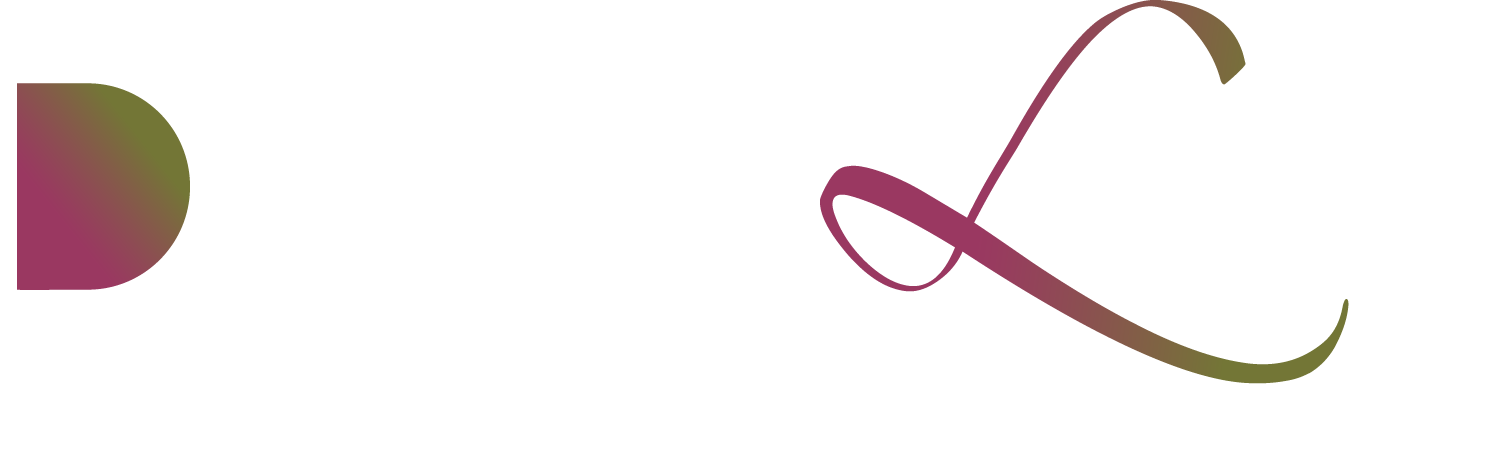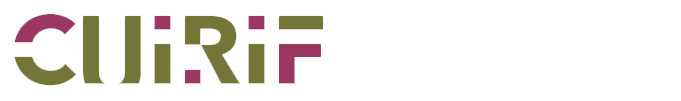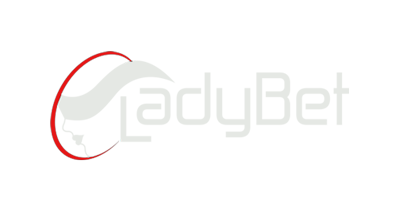Abstract
Nel mondo digitale contemporaneo, la sopravvivenza assume forme inedite: gli autori tornano in vita come repliche algoritmiche, mentre le loro opere svaniscono intrappolate in formati obsoleti e piattaforme perdute. L’indagine sul conflitto tra memoria e oblio, identità e conservazione, mostra come le logiche della proprietà e del controllo ridisegnino il destino postumo di persone e contenuti. Il paesaggio normativo è frammentato e la memoria rischia di diventare privilegio anziché bene condiviso. Ma sullo sfondo, si intravede la possibilità di un diverso modo di sopravvivere nel digitale.
Introduzione
L’era digitale ci era stata presentata come l’epoca della conservazione perpetua, ma questa promessa si sta rivelando ingannevole.
Nel secondo quarto del XXI secolo assistiamo a un’inversione che il diritto fatica ancora a nominare: mentre la tecnologia rende sempre più “immortale” l’autore, l’opera digitale diventa sempre più fragile.
Da un lato, l’identità personale — volto, voce, stile — viene estratta dal corpo biologico e resa disponibile a nuove occorrenze potenzialmente infinite. L’autore non è più solo ricordato: viene riattivato. Dall’altro, le opere nate digitali scompaiono con una velocità inedita, vittime dell’obsolescenza tecnologica, della chiusura dei server, della putrefazione dei link.
Il risultato è un capovolgimento: salviamo le persone come simulazioni e perdiamo le opere come memoria collettiva.
E l’attuale assetto normativo sta contribuendo a una distorsione profonda: l’identità viene trasformata in asset, l’opera in infrastruttura sacrificabile.
L’eternità sintetica e la scomposizione dell’autorialità
L’industria culturale contemporanea non si limita più a registrare una performance: la genera. Nel Novecento, il cinema catturava la luce riflessa da un corpo in un momento determinato. Oggi quella registrazione viene scomposta, analizzata, addestrata — non per conservare una performance, ma per produrne di nuove, sganciate dal tempo biologico.
L’identità diventa modulare. E il diritto non ha ancora chiarito se si tratti di tutela, estensione o espropriazione.
Harrison Ford e l’illusione della continuità personale
Il caso di Indiana Jones e il Quadrante del Destino segna uno spartiacque: la sequenza ambientata nel 1944 non è un artificio eccezionale, ma una dimostrazione di possibilità. La tecnologia sviluppata da Industrial Light & Magic analizza decenni di materiale d’archivio — film, scene scartate, prove mai pubblicate — e li trasforma in un modello predittivo del volto passato dell’attore. L’archivio, da deposito storico, diventa miniera di dati biometrici.
Ne deriva una dissonanza che non è tecnica, ma ontologica: il volto appartiene a un passato sintetizzato, la voce a un presente biologico. Lo stesso Ford ha definito l’esperienza “fantastica ma anche spooky“, aggiungendo però che un Indiana Jones interamente generato da IA “non accadrà mai”. Una distinzione sottile ma cruciale: l’attore accetta di guidare la tecnologia, non di esserne sostituito.
Non siamo disturbati dall’artificialità in sé, ma dal fatto che il tempo venga trattato come variabile opzionale.
Il rischio è che la giovinezza diventi proprietà separabile dal soggetto. Se il modello digitale del “giovane Ford” è tecnicamente autonomo, chi ne dispone nel lungo periodo?
James Dean e la produzione post-mortem dell’autore
Se il caso Ford è riattivazione assistita, quello di James Dean segna un passaggio ulteriore: la produzione di nuove performance in assenza totale del soggetto.
Nel 2019, Magic City Films annunciò di aver “scritturato” Dean — morto nel 1955 — per un ruolo nel film sulla guerra del Vietnam Finding Jack. Il progetto si è arenato, ma l’idea non è morta con esso. Nel 2023 è emerso Back to Eden, un film di fantascienza che prometteva un “James Dean 2.0”: un umano digitale multipiattaforma, dalla realtà virtuale al gaming.
Mark Roesler, CEO di CMG Worldwide — l’agenzia che gestisce i diritti di Dean — ha dichiarato che la tecnologia apre “nuove opportunità” per i clienti defunti. La morte come ostacolo logistico, il lutto come occasione di business. Difficile immaginare una sintesi più efficace della Digital Afterlife Industry.
Non è solo l’assenza di consenso. È la sostituzione dell’agency artistica: Dean non sceglie, non interpreta, non rifiuta. La sua filmografia — tre sole opere, un corpus chiuso e coerente — non viene arricchita, ma diluita. L’attore non è celebrato: è prolungato artificialmente, fino a perdere il confine tra ciò che è stato e ciò che viene proiettato su di lui[1].
Quando la fisicità non serve più: lo stile come modello
Ma la resurrezione artificiale non riguarda soltanto volto e voce. Le tecnologie generative sono in grado di apprendere e replicare una grammatica espressiva riconoscibile. Non solo la fisicità, ma ad esempio anche il tratto, la composizione, la tavolozza, la struttura formale.
Nel gennaio 2024 è emerso un foglio di calcolo interno di Midjourney con oltre 16.000 nomi di artisti i cui stili possono essere imitati su richiesta — da Andy Warhol a un bambino di sei anni vincitore di un concorso di illustrazione. Il prompt “gerald brom chef” genera demoni gotici in cucina, replicando fedelmente lo stile dark fantasy dell’illustratore. Brom è oggi tra i querelanti nella class action Andersen v. Stability AI, tuttora pendente.
L’autorialità viene scomposta nei suoi elementi formali. Se nel caso degli attori la tecnologia tenta di preservare l’illusione di continuità personale, nella riproduzione stilistica la persona diventa irrilevante. Ciò che sopravvive non è l’autore, ma il suo modo di produrre senso.
Training set, opere orfane e l’illusione del fair use
A differenza del volto, lo stile non è contenuto in un singolo oggetto: emerge per accumulo, per sedimentazione di scelte formali. Addestrare un modello “alla maniera di” un autore implica l’attraversamento di un corpus ampio e spesso giuridicamente opaco.
Gran parte dei dataset utilizzati — come LAION-5B, 5,85 miliardi di immagini da scraping — è composta da opere di cui l’autore non è identificabile o non è più in grado di esercitare i propri diritti. Opere che il diritto non riesce a collocare, ma che la tecnologia utilizza senza difficoltà.
Negli Stati Uniti, il ricorso al fair use viene presentato come soluzione: l’addestramento non riproduce le opere, ne estrae pattern. In Europa, la Direttiva 2019/790 ha introdotto eccezioni specifiche per il text and data mining, con un meccanismo di opt-out che consente ai titolari di riservare i propri diritti. Ma l’opt-out presuppone un titolare identificabile e attivo — condizione che le opere orfane, per definizione, non soddisfano.
Quando poi ciò che viene appreso è uno stile riconoscibile, entrambe le soluzioni vacillano. Non perché il modello copi una singola opera, ma perché ricostruisce una coerenza espressiva che il diritto aveva sempre considerato inseparabile dall’autore.
Una possibile apertura viene dal caso Andersen v. Stability AI citato: il giudice Orrick ha ammesso le rivendicazioni ai sensi del Lanham Act, la legge federale sulla concorrenza sleale. Se accolte, sarebbe la prima volta che lo stile artistico riceve protezione giuridica autonoma: non come opera, ma come segno distintivo dell’autore.
Il nodo resta irrisolto: lo stile, tratto più distintivo dell’autorialità, è oggi il suo punto di maggiore vulnerabilità. Non perché non sia creativo, ma perché è diventato computabile.
La morte dell’opera e la fragilità dell’infrastruttura
L’opera analogica è un oggetto. L’opera digitale è una performance tecnica: esiste solo finché un determinato insieme di hardware, software, protocolli e licenze continua a funzionare. Quando quell’ecosistema si interrompe, l’opera non si degrada, cessa di esistere.
Flashpoint e la preservazione come disobbedienza
La fine del supporto per Adobe Flash Player, il 31 dicembre 2020, ha reso inaccessibili vent’anni di produzione culturale web: giochi, animazioni, interfacce artistiche. Le grandi corporation hanno giustificato l’abbandono con argomenti di sicurezza, senza proporre alcun progetto di preservazione.
Nel vuoto istituzionale si è inseritoFlashpoint Archive, un’iniziativa comunitaria che ha salvato oltre 170.000 giochi e 30.000 animazioni. Non attraverso semplice archiviazione: molti contenuti Flash richiedevano server esterni ormai spenti o controlli DRM. Flashpoint ha sviluppato un’infrastruttura di emulazione che intercetta le richieste di rete e simula i server originali, ingannando il software facendogli credere di essere ancora online.
L’operazione si muove in zona grigia. Tecnicamente, la ridistribuzione viola il copyright. Ma Flashpoint opera senza scopo di lucro, con politica di rimozione su richiesta — come nel caso dello studio Nitrome, che ha ottenuto la cancellazione dei propri giochi.
È una questione sistemica: se gli archivisti avessero atteso l’autorizzazione di centinaia di migliaia di creatori — molti irrintracciabili, molte opere orfane — la preservazione sarebbe stata impossibile. Il rispetto integrale del copyright conduce, in questo contesto, alla distruzione della memoria. La conservazione diventa, inevitabilmente, disobbedienza civile tecnologica.
NFT e la volatilità della “proprietà” digitale
Il mercato degli NFT è stato costruito attorno a una promessa opposta: permanenza, autenticità, immutabilità. La blockchain avrebbe risolto il problema della conservazione e della titolarità. I casi concreti dimostrano che … dipende.
Nell’agosto 2022, il progetto Moonbirds annunciò il passaggio dell’intera collezione a licenza Creative Commons Zero. I possessori — che avevano investito decine di migliaia di dollari per i diritti esclusivi di sfruttamento commerciale — si ritrovarono con immagini liberamente utilizzabili da chiunque.
Il problema è strutturale: un NFT non contiene quasi mai l’opera, solo un puntatore. Se il server che ospita il file viene spento, il token resta ma punta a un errore 404. È il link rot: la proprietà digitale come proprietà senza memoria.
Eppure, esistono eccezioni. Quando nel novembre 2021 il fondatore di Hic Et Nunc chiuse improvvisamente la piattaforma, la comunità temeva di aver perso tutto. Ma gli smart contract erano on-chain e i file su IPFS, una rete di storage decentralizzata. Nel giro di settimane, la comunità costruì mirror alternativi come Teia, ripristinando l’accesso alle opere e allo storico delle transazioni.
La differenza non è ideologica, è architettonica: la resilienza richiede decentralizzazione reale, non solo del registro, ma anche dello storage e dell’interfaccia. Quando manca, code is law significa solo che chi scrive il codice decide la legge.
Guggenheim e la conservazione come traduzione
Le istituzioni museali che si confrontano con l’arte digitale hanno dovuto riconoscere questa fragilità e rispondervi con strategie radicali.
Il Guggenheim si è trovato a preservare opere seminali della net art come Brandon (1998-1999) di Shu Lea Cheang e Unfolding Object (2002) di John F. Simon Jr., entrambe create in Java applet — una tecnologia che i browser moderni hanno smesso di supportare. A differenza di un dipinto, che può essere recuperato, un software obsoleto non può essere “restaurato”.
La soluzione adottata è stata la code resituation: invece di riscrivere il codice da zero, i conservatori hanno tradotto il Java originale in JavaScript e HTML5, cercando di mantenere intatta la logica algoritmica e l’estetica. Il comportamento visibile è identico, ma il materiale sottostante è completamente nuovo.
È il paradosso della Nave di Teseo in versione digitale: se ogni componente viene sostituito, l’opera è ancora la stessa? La risposta non può essere binaria. L’identità dell’opera non risiede nel supporto, ma nella continuità della sua esperienza. L’opera muore nella forma originale per risorgere in una forma compatibile: la memoria viene salvata al prezzo della sua trasformazione.
L’opera come residuo sacrificabile
Questi tre casi mostrano un quadro coerente: l’opera digitale non viene distrutta perché priva di valore, ma perché non è più economicamente o tecnicamente conveniente mantenerla accessibile.
Flashpoint deve violare il copyright per salvare la memoria. Gli NFT promettono proprietà perpetua su fondamenta di sabbia. I musei accettano che conservare significhi trasformare.
Il diritto, così com’è strutturato, interviene tardi e male: protegge la titolarità formale, ma non la fruibilità; difende l’oggetto giuridico, ma non la memoria culturale. È in questo scarto che si consuma la morte dell’opera digitale: silenziosa, sistemica, senza trauma apparente.
Il campo di battaglia: identità, memoria e scelte di valore
Le dinamiche descritte sono anche – e soprattutto – il risultato di scelte normative che determinano cosa merita protezione e cosa può essere sacrificato. Resta un divario tra chi produce la tecnologia e l’industria culturale che la monetizza, e chi quel patrimonio culturale lo ha generato e vorrebbe continuare a custodirlo.
Stati Uniti: l’identità come proprietà scalabile
Negli Stati Uniti, la risposta alla replicabilità dell’autore si è sviluppata lungo una direttrice coerente: trasformare l’identità in proprietà.
Il NO FAKES Act, proposta di legge federale ripresentata nel 2025, istituirebbe un diritto di proprietà su voce e immagine con protezione fino a 70 anni post-mortem, speculare alla durata del copyright. Il diritto sarebbe trasferibile e licenziabile, con ampio sistema di notice-and-takedown per le piattaforme.
Gli stati chiave hanno già agito autonomamente. La California (AB 1836) protegge per 70 anni le “repliche digitali” in opere audiovisive. Il Tennessee (ELVIS Act) è il primo a tutelare esplicitamente la voce come proprietà autonoma, con durata potenzialmente perpetua: la protezione si estende finché i diritti vengono sfruttati commercialmente[2].
L’impostazione ha una coerenza interna: incentiva la contrattualizzazione, tutela gli eredi, garantisce certezza agli operatori. Ma il prezzo è alto. Quando l’identità diventa proprietà, la sua alienabilità diventa virtù. Nulla impedisce che una voce venga ceduta in perpetuo, che un volto sia vincolato per decenni, che uno stile performativo venga incorporato in modelli senza più alcun legame con chi lo ha generato. L’immortalità giuridica non coincide con la memoria, coincide con la rendita.
Europa: tutelare senza controllare
L’Europa non difetta di principi. La tradizione giuridica continentale ha costruito il concetto di dignità umana come limite invalicabile, e il GDPR ne è l’applicazione più ambiziosa in ambito digitale. Ma esclude i defunti dall’ambito di applicazione, segnando una soglia netta: la protezione dei dati è un diritto dei vivi.
Le normative nazionali colmano il vuoto solo in parte. In Italia, l’art. 2-terdecies del Codice Privacy consente a eredi e portatori di interesse proprio di esercitare i diritti sui dati del defunto: una formula più ampia di quanto appaia, ma pensata per il lutto e la memoria familiare, non per governare la resurrezione commerciale di un attore.
Il vero limite europeo, però, è un altro: si possono avere i principi migliori del mondo, ma se i server sono altrove, i modelli si addestrano altrove, le piattaforme decidono altrove, la sovranità normativa resta incompiuta.
Eppure, segnali di resistenza emergono. In Italia, dopo lo sciopero dei doppiatori del 2023, dal giugno 2024 i contratti con le principali major includono una clausola che vieta l’uso delle voci per l’addestramento di modelli IA senza consenso esplicito. La voce come ultima frontiera dell’alienabilità e la prima, in Italia, su cui si è ottenuta una tutela contrattuale.
Una possibile indicazione viene dal lavoro di Luciano Floridi e Carl Öhman sulla Digital Afterlife Industry: trattare i resti digitali come si trattano i resti umani nei musei archeologici, cioè non proprietà da sfruttare, ma tracce da custodire nel rispetto della dignità. Il modello è il Codice Etico dell’ICOM: i resti non possono essere usati come mero strumento di profitto, e chi li gestisce ha obblighi che prescindono dalla titolarità formale.
Non è una soluzione, è un cambio di paradigma. Ma forse è l’unico che impedisce di ridurre la memoria digitale a una scelta tra profitto e oblio.
Conclusioni
L’era digitale non ha mantenuto la promessa dell’eternità. Ha scelto cosa rendere eterno.
Abbiamo costruito un sistema che trasforma l’identità in asset e tollera l’opera fintanto che è funzionale. Che protegge il volto di un attore morto settant’anni fa e lascia scomparire vent’anni di cultura web. Che garantisce agli eredi la rendita perpetua su una voce, ma non riesce a conservare il software che ha definito un’epoca.
Invertire questa tendenza richiede tre mosse: trasparenza sull’artificialità; preservazione come eccezione strutturale al copyright; limiti invalicabili all’alienabilità dell’identità.
L’autore risorge, l’opera muore.
Un sistema capace di fare recitare per sempre i morti, ma incapace di conservare le opere dei vivi, non è un sistema che preserva la cultura: è un sistema che la condanna.
Se vogliamo invertire i termini, dobbiamo smettere di trattare la memoria come sottoprodotto del mercato e iniziare a trattarla per ciò che è: un bene comune.
NOTE
[1] Il caso di Ian Holm in Alien: Romulus (2024) ha mostrato un ulteriore scarto: nonostante il consenso esplicito della vedova, la resurrezione digitale dell’attore — ottenuta con un ibrido di animatronica, deepfake e clonazione vocale IA — è stata definita dal pubblico “spaventosa” e “irrispettosa”. Il consenso degli eredi, dunque, non equivale ad assoluzione morale.
[2] L’efficacia di questi strumenti è stata testata nel caso George Carlin / Dudesy (2024): un podcast aveva pubblicato uno speciale comico presentandolo come “scritto e interpretato da un’IA addestrata su Carlin”. La causa intentata dagli eredi si è conclusa con un accordo: i creatori hanno ammesso che il testo era stato scritto da un umano e l’IA usata solo come filtro vocale. Il caso ha stabilito che l’etichetta “generato da IA” non può fungere da scudo per l’appropriazione dell’identità.
PAROLE CHIAVE: AI and Copyright / code is law / Cultural Heritage / Data Dignity / Deepfake Ethics / Digital After life / Digital Preservation / Diritto Autore / Identità Digitale / Memoria digitale / NFT law
Tutti i contenuti presenti in questa rivista sono riservati. La riproduzione è vietata salvo esplicita richiesta e approvazione da parte dell’editore Digitalaw Srl.
Le foto sono di proprietà di Marcello Moscara e sono coperte dal diritto d’autore.