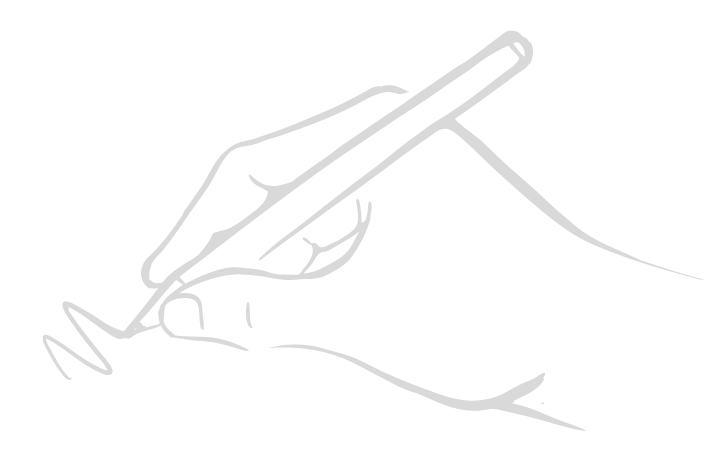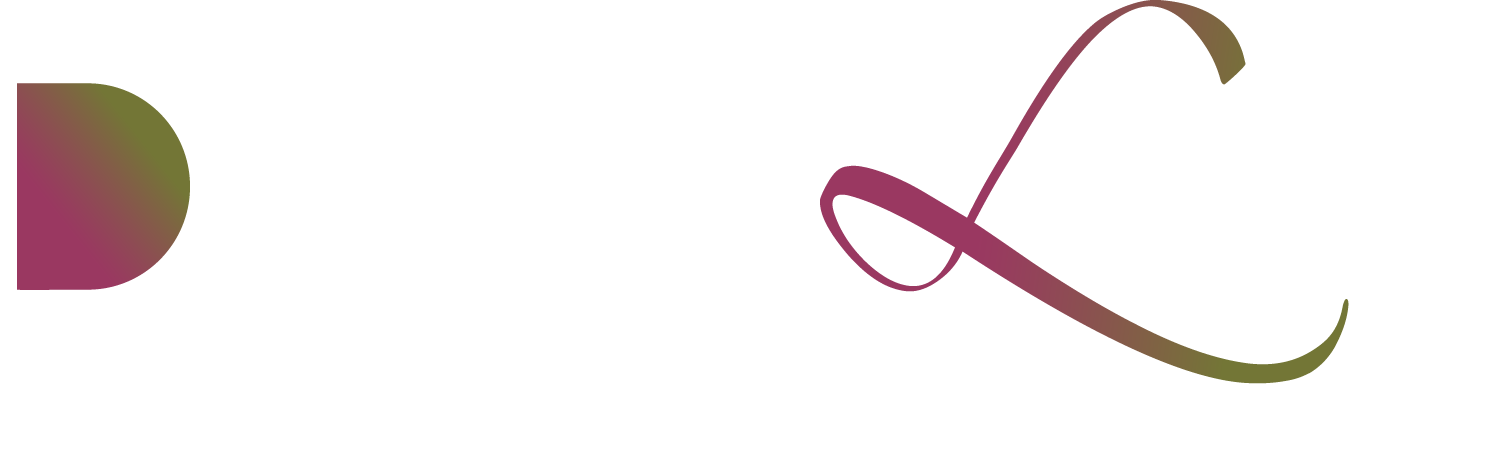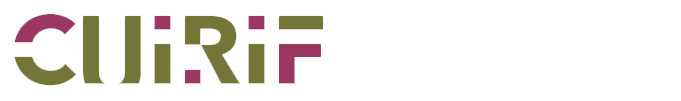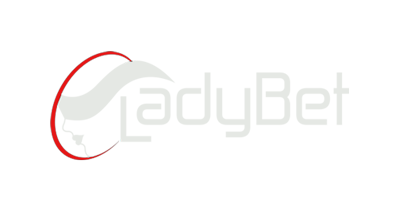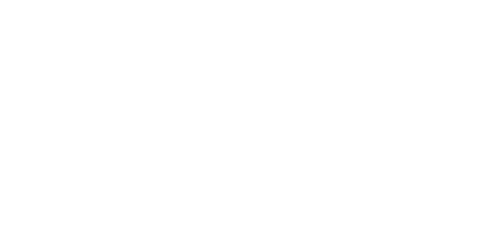Abstract
La presenza della Cina in Africa è un tema su cui convergono aspetti economici, tecnologici, politici e sociali. La sete di espansione della Cina, spinta da ragioni economiche e geostrategiche, produce evidenti benefici nel continente africano che vanno dall’inclusione finanziaria allo sviluppo delle infrastrutture digitali, alla modernizzazione dei sistemi di pagamento. E se il prezzo da pagare alla Repubblica Popolare Cinese fosse la dipendenza tecnologica, il controllo dei dati, il rischio di esclusione finanziaria e la perdita di sovranità monetaria?
Cooperazione e Sviluppo: una prospettiva storica
La collaborazione tra Cina e Africa ha radici profonde. Nel 1949, con la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, Mao Zedong iniziò a stabilire legami con i movimenti di liberazione africani, supportando le loro lotte per l’indipendenza. La conferenza di Bandung del 1955 pose le basi per la cooperazione tra Asia e Africa, seguita dal tour diplomatico dell’allora primo ministro cinese Zhou Enlai in diversi paesi africani tra il dicembre 1963 e il febbraio 1964. Un esempio emblematico di questa cooperazione è stata la costruzione della ferrovia Tazara (Tanzania-Zambia Railway), completata nel 1975, che ha rappresentato uno dei primi simboli dell’aiuto cinese e di solidarietà tra i due popoli.
L’Africa riveste un ruolo di crescente importanza per diverse ragioni. Innanzitutto, è un fornitore di risorse naturali cruciali per l’industria cinese. Il continente è ricco di materie prime, tra cui petrolio, minerali e metalli, e molte società cinesi sono attivamente impegnate nell’estrazione di queste risorse in diversi paesi africani, acquisendo oro in Mali, petrolio in Ghana e Ciad, cobalto nella Repubblica Democratica del Congo e rame in Zambia.
In secondo luogo, il continente africano rappresenta un mercato in crescita con una popolazione giovane e in rapida espansione. Molti investitori cinesi hanno colto l’opportunità di produrre in Africa per il mercato africano, come dimostra la fabbrica di cellulari Transsion in Etiopia. Nella Top five dei maggiori produttori di smartphone al mondo, dietro Samsung, Apple, Xiaomi e Oppo, nel 2017 – nove anni dopo aver commercializzato il suo primo dispositivo in Nigeria – ha detronizzato Samsung, affermandosi come l’impresa numero uno nel settore della telefonia nel continente. Quasi del tutto ignota nei paesi occidentali, l’azienda con sede a Shenzhen, nel sud della Cina, ha costruito il suo successo grazie ai consumatori africani: i suoi telefoni sono stati i primi a offrire più slot per schede Sim, un rapporto qualità-prezzo imbattibile, batterie particolarmente durevoli e tastiere che integrano lingue africane come l’amarico, parlato in Etiopia, o anche lo swahili e l’hausa.
In terzo luogo, l’espansione economica in Africa consente alla Cina di aumentare la sua influenza a livello globale e di bilanciare l’influenza occidentale.
L’Occidente, invece, ha ignorato – o quasi – l’Africa per troppi anni, spinto dai sensi di colpa del colonialismo, si è ritagliato il ruolo di raccontare un’Africa in cui regnano solo guerre e miseria, descrivendola come luogo di carestie, sciagure e saccheggi, con il risultato di consegnare il continente nelle mani di Cina, Russia, Turchia. D’altro canto, altri paesi come India, Giappone, Corea del Sud e Brasile sono in lizza per conquistare spazi di manovra.
L’errore dell’Occidente è quello di pensare ai governi africani come povere vittime del Dragone o delle altre superpotenze e di vedere l’espansione cinese come l’ennesima rapina delle risorse africane. Bisogna considerare, invece, che le classi dirigenti africane in diverse occasioni hanno saputo mettere in concorrenza tra loro Cina, Russia e Stati Uniti e, spesso, l’espansione è avvenuta “su invito”.
La Nuova Via della Seta (Belt and Road Initiative)
A partire dagli anni ’90, gli scambi tra Cina e Africa si sono intensificati, con una crescita esponenziale a partire dal 2000, grazie alla creazione del Forum sulla Cooperazione Sino-Africana (FOCAC). La Cina è diventata il maggior partner commerciale del continente africano. Nel 2018, il presidente cinese Xi Jinping ha offerto altri 60 miliardi di dollari in investimenti in Africa, tra prestiti e infrastrutture. Si stima che dal 2000 al 2022, le banche cinesi abbiano promesso e prestato ai governi africani circa 170 miliardi di dollari per finanziare innumerevoli progetti.
La Belt and Road Initiative (BRI), lanciata dalla Cina, ha visto l’Africa come un tassello fondamentale per collegare Cina, Europa e Asia centrale attraverso reti infrastrutturali, energetiche e di comunicazione.
Esempi significativi sono la ferrovia che collega Addis Abeba in Etiopia al porto di Gibuti, il porto di Lekki in Nigeria, l’autostrada Abuja-Kaduna e la diga di Bui in Ghana. Questi progetti sono finanziati in parte da fondi cinesi, spesso statali, come le banche di sviluppo (China Development Bank, China Eximbank), che concedono prestiti ai governi africani per la realizzazione di infrastrutture, sovente a condizione che queste vengano appaltate a imprese cinesi.
L’Africa è sempre più cinese
Per chi ha voglia di aprire gli occhi, l’espansione cinese in Africa è ormai realtà. Dal finanziamento delle infrastrutture all’insegnamento della lingua nelle scuole elementari in paesi quali Kenya, Tanzania, Rwanda, Uganda, Zimbabwe e Sud Africa, sino a giungere all’introduzione della propria valuta, attraverso la sua digitalizzazione, e la creazione di portafogli digitali che accompagnano la propria telefonia hardware, unitamente alle reti di connessione e alla creazione di data center in Senegal, Camerun, Kenya e Zambia.
Da un lato abbiamo un continente dalle potenzialità enormi, che vuole crescere e riscattarsi da una storia coloniale, dall’altro c’è un Paese-continente che vuole consolidare il proprio status di potenza globale e, al tempo stesso, spinge per una decisa trasformazione dell’ordine internazionale. Almeno a giudicare dai rispettivi obiettivi, Africa e Cina non potrebbero essere più complementari.
È facile, dunque, capire perché molti governi africani non considerino la presenza cinese una minaccia, quanto piuttosto un’occasione da sfruttare al meglio. La Cina presta denaro senza imporre condizioni ideologiche o valoriali, costruisce infrastrutture necessarie che, di fatto, migliorano la quotidianità delle popolazioni locali e rifornisce i mercati con prodotti made in China altrimenti off limits per la stragrande maggioranza degli africani. Se la Cina, nell’ambito della sua strategia go-global, è ben lieta di incoraggiare le proprie aziende a investire e operare all’estero, cercando di stabilire e promuovere standard, principi ideologici e norme digitali cinesi, l’Africa è altrettanto felice dei progressi tecnici conseguiti.
L’Espansione dei Data Center e la questione della Sovranità dei dati
L’Africa rappresenta solo l’1% della capacità globale dei data center, anche se ospita il 17% della popolazione mondiale. Quindi, vi è un potenziale significativo per gli investitori nel settore dei data center, complice anche la corsa allo sviluppo dell’intelligenza artificiale (IA) che spinge la domanda di capacità di elaborazione dati in tutto il mondo.
La crescente domanda di connettività e archiviazione in tutto il continente africano ha portato le aziende tecnologiche globali, tra cui Amazon e Microsoft, così come la cinese Huawei Technologies, ad aumentare gli investimenti nei data center africani. Gli investimenti maggiori sono stati fatti in Sudafrica, a cui si sono aggiunti Egitto, Kenya, Marocco, Nigeria. Anche la multinazionale Oracle ha annunciato di recente il suo piano di aprire due nuovi data center in Marocco, dove, per promuovere ulteriormente la crescita del settore, il governo ha anche istituito Zone di accelerazione industriale in cui gli operatori possono beneficiare di vantaggi fiscali e altri incentivi finanziari. Ciò evidenzia la visione strategica del governo marocchino nel posizionare il paese come un Hub chiave per l’innovazione e la crescita economica nel Nord Africa.
Microsoft, insieme alla società di tecnologia IA con sede negli Emirati Arabi Uniti G42, ha annunciato nel maggio 2024 investimenti per circa un miliardo di dollari per il Kenya, una parte dei quali andrà alla costruzione di un data center “verde” per gestire la nuova East Africa Cloud Region di Microsoft Azure, nonché allo sviluppo di modelli AI LLM sia in swahili che in inglese. Il nuovo data center funzionerà con “energia geotermica rinnovabile” e sarà dotato di “tecnologia all’avanguardia per la conservazione dell’acqua”. Con la nuova regione cloud, le aziende sperano di accelerare la trasformazione digitale in Kenya e nell’Africa orientale.
In Nigeria, Airtel Africa e l’operatore di data center Nxtra by Airtel, hanno iniziato la costruzione del loro primo data center hyperscale nel continente a marzo 2024. La struttura da 38 MW a Lagos dovrebbe essere disponibile dall’inizio del 2026 e la stessa società ha in programma un data center da 7 MW a Nairobi, in Kenya.
In Egitto, la cinese Huawei ha lanciato una regione cloud al Cairo, rivendicando la prima disponibilità di cloud pubblico nella regione del Nord Africa. Huawei ha anche svelato il suo nuovo LLM di lingua araba insieme ai piani per investire 300 milioni di dollari in cinque anni per sviluppare ulteriormente la nuova regione cloud nel paese. L’ambizioso piano, chiamato “Intelligent Future” prevede investimenti per la costruzione di un centro elaborazione dati, sostegno a distributori e partner locali, programmi di formazione per specialisti tecnologici e sviluppatori in materia di intelligenza artificiale e tecnologie associate. Entrambe le parti beneficeranno del piano: da un lato la Cina, tramite la compagnia delle telecomunicazioni, si pone come alternativa all’influenza occidentale; dall’altra, i Paesi del Nord Africa si giovano degli investimenti in un settore che ha grandi potenzialità di sviluppo, offrendo nuove opportunità per una forza lavoro sempre più specializzata.
Il Nord Africa – grazie alla posizione strategica della regione posta tra Mediterraneo, Asia, Africa Subsahariana – è una regione chiave per gli interessi della Cina che, grazie a Huawei, ha uno strumento fondamentale per ampliare la sua influenza nell’area. Huawei fornisce anche servizi di e-Goverment che vanno dalle elezioni con voto elettronico ai documenti digitali sino a giungere ai sistemi di ID digitale e pagamento delle tasse.
Ciò può aiutare ad aumentare la sorveglianza statale, ma può essere visto anche quale strumento di inclusione e coesione attraverso la trasparenza che i sistemi di digitalizzazione possono assicurare, evitando le opacità in cui la corruzione e la burocrazia hanno sempre terreno fertile
Avere accesso ai dati può significare incidere sulle scelte dei consumatori, sull’economia, sulle politiche nazionali e internazionali, ma lo sfruttamento dei dati, da parte di privati, grandi aziende, multinazionali, soprattutto in Africa non sempre si sposa con la trasparenza. Contrariamente a quanto avviene in Europa, un cittadino africano non ha facoltà di chiedere l’accesso ai propri dati a grandi aziende come Google, Meta o Tik Tok.
Tuttavia, le cose potrebbero presto cambiare, atteso che la Commissione africana per i diritti umani e dei popoli (ACHPR), nel novembre 2024, ha adottato una Risoluzione sulla promozione e lo sfruttamento dell’accesso ai dati come strumento per promuovere i diritti umani e lo sviluppo sostenibile nell’era digitale. La risoluzione richiede agli stati membri dell’Unione Africana di:
- a) garantire che le pratiche di raccolta, elaborazione, archiviazione e accesso ai dati siano trasparenti e responsabili;
- b) garantire che i dati detenuti da istituzioni pubbliche e da organismi che ricevono fondi pubblici, nonché quelli detenuti da attori privati, laddove vi sia un prevalente interesse pubblico all’accesso, siano resi pubblici by default.
L’eYuan e la “colonizzazione digitale”
Oltre alla promozione della sua influenza tecnologica, la Cina in Africa si è concentrata anche sulle sue politiche economiche, con particolare attenzione agli sviluppi nel campo delle monete digitali e dei pagamenti elettronici. La Cina ha fatto un passo avanti nell’innovazione finanziaria con l’introduzione dell’e-Yuan, la versione digitale della valuta cinese (Renminbi, RMB), utilizzata come leva per rafforzare la propria influenza economica, facilitando i pagamenti transfrontalieri, riducendo i costi delle transazioni internazionali e aumentando la tracciabilità economica.
Il Digital renminbi, approvato dal governo cinese nel 2017, è stato introdotto dalla Banca centrale cinese e, a differenza delle criptovalute tradizionali, è progettato per avere un valore stabile e la sua conversione è pari a quella del denaro fisico, evitando così le fluttuazioni di valore spesso associate alle criptovalute. Importanti attori del settore digitale, come Alibaba, Huawei e UnionPay, sono stati invitati a partecipare allo sviluppo di questa valuta.
Si ispira alla tecnologia Blockchain, ma crea regole autonome e non dipende direttamente da essa. A differenza del Bitcoin e di altre criptovalute, non è considerato un mezzo di investimento, ma piuttosto un mezzo di pagamento utilizzato per transazioni e acquisti di beni e servizi. Essendo emesso dal governo cinese, è soggetto a normative e politiche di monitoraggio.
Ciò consente al governo di monitorare l’economia e le transazioni della popolazione in modo più accurato rispetto alle criptovalute. In tal modo, si intende sfidare il predominio del dollaro USA. Una caratteristica distintiva dell’e-Yuan è la capacità di effettuare pagamenti mobili anche offline. Alcune banche centrali africane hanno iniziato a sperimentarne l’utilizzo.
La Nigeria rappresenta uno degli esempi più rilevanti di paese africano che sta testando la digitalizzazione dei pagamenti cinesi. Anche il Sud Africa ha avviato discussioni con la Cina riguardo all’adozione di tecnologie digitali e sistemi di pagamento avanzata.
La valuta digitale e l’eWallet sugli smartphone Huawei stanno suscitando preoccupazioni a livello internazionale. Si teme che l’introduzione di una nuova valuta, non più limitata nella sua circolazione dai confini nazionali, possa influire negativamente sulle politiche monetarie degli stati con economie deboli, minando così la loro indipendenza economica.
Senza cadere nel catastrofismo tipico di alcune visioni occidentali, è importante riconoscere le opportunità che l’adozione dell’eYuan potrebbe offrire in Africa:
- Inclusione finanziaria, poiché potrebbe facilitare l’accesso ai servizi finanziari per le persone non bancarizzate, permettendo a più individui di partecipare all’economia digitale;
- Sviluppo delle infrastrutture digitali, con un’accelerazione nel loro sviluppo per supportarne l’uso, creando nuove opportunità per le imprese locali;
- Integrazione nelle piattaforme di e-commerce, come AliExpress e Jumia, che potrebbero adottarlo come metodo di pagamento, ampliando le opzioni disponibili per i consumatori e le imprese.
Solleva preoccupazioni, soprattutto in Occidente il rischio di una “colonizzazione digitale” del continente africano. L’adozione dell’eYuan potrebbe incrementare la dipendenza tecnologica dell’Africa dalla Cina, limitando la capacità dei paesi africani di sviluppare autonomamente le proprie infrastrutture e valute digitali.
L’eYuan potrebbe consentire alla Cina di raccogliere una vasta quantità di dati sui consumatori africani, potenzialmente utilizzabili per finalità commerciali o politiche. Qualora l’eYuan dovesse affermarsi come valuta dominante in Africa, si potrebbe verificare l’esclusione dall’economia digitale di coloro che non dispongono delle tecnologie necessarie per utilizzarla. Infine, una sua adozione diffusa potrebbe erodere la sovranità monetaria dei paesi africani, limitando la capacità delle banche centrali africane di implementare politiche monetarie indipendenti.
Il rischio, non da poco, sul quale dovrebbero riflettere i governi del continente, è quello di restare intrappolati in una dipendenza tecnologica (e non solo quella) con la Repubblica Popolare Cinese. Al momento un simile rischio sembra, però, essere più una preoccupazione degli analisti occidentali che non dei diretti interessati: i leader africani.
PAROLE CHIAVE: colonialismo digitale / data center / eYuan / sorveglianza
Tutti i contenuti presenti in questa rivista sono riservati. La riproduzione è vietata salvo esplicita richiesta e approvazione da parte dell’editore Digitalaw Srl.
Le foto sono di proprietà di Marcello Moscara e sono coperte dal diritto d’autore.