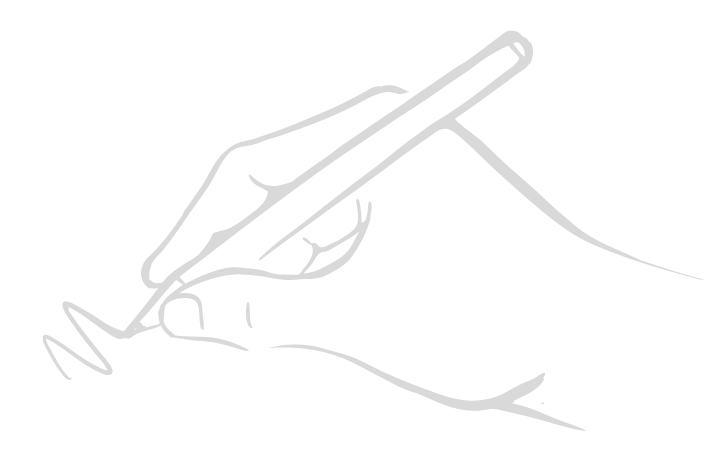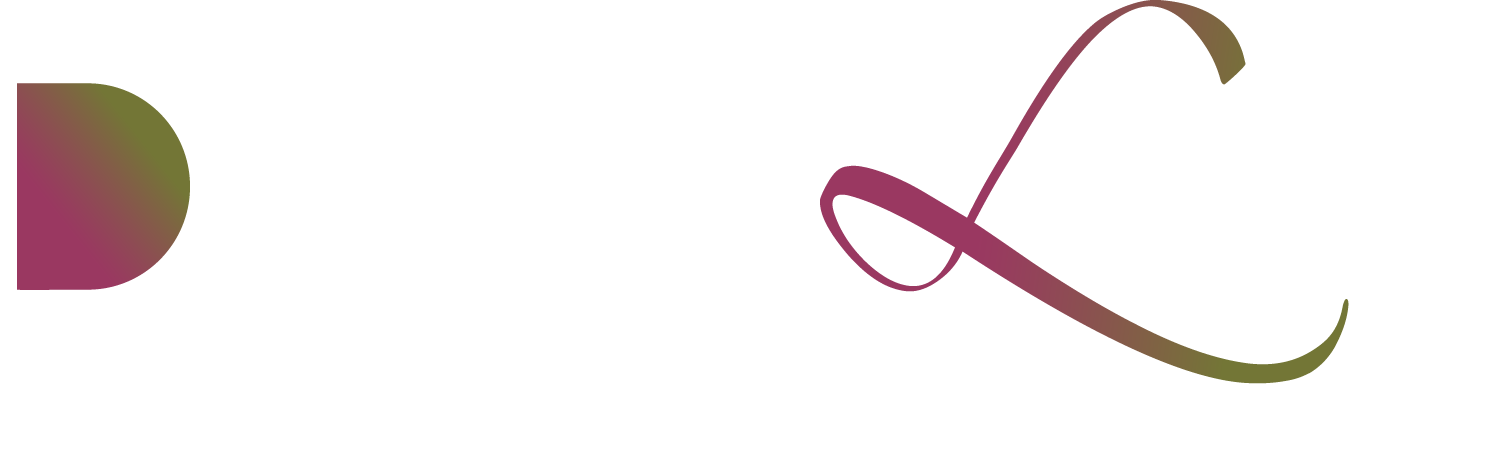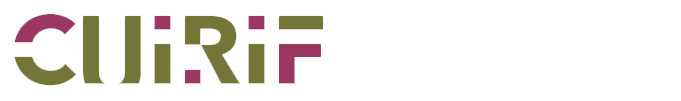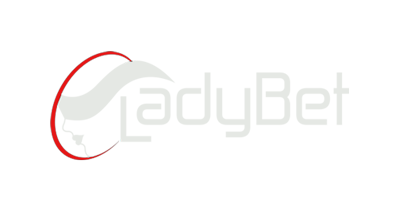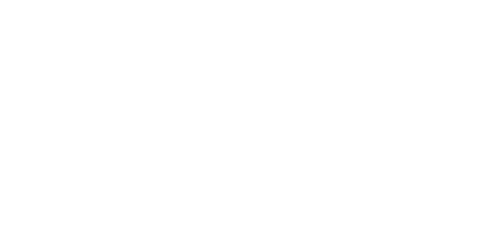Abstract
Per secoli, ancora prima della diffusione della stampa, preservazione e possesso dell’informazione passavano dal diritto alla copia: faticoso, costoso, ma necessario ai tempi di amanuensi e miniaturisti, rapido ai tempi delle macchine da stampa e poi di nastri e fotocopiatrici. Nell’eterna battaglia tra entropia e sapere, avere a disposizione più copie, anche corrotte, dell’informazione originale ci ha consentito di salvare più dati di quelli che abbiamo perso. Ma nel mondo “tecnofeudale” delle librerie digitali, dei contenuti on demand, del digital delivery e di pagine internet abbandonate al loro destino, siamo al momento in cui la tendenza potrebbe invertirsi.
Introduzione
È il 1335: Oliviero Forzetta si reca da due fraticelli dei SS. Giovanni e Paolo per comprare testi di Seneca, Orosio e Aristotele. È il 2025, qualcuno ha comprato una copia digitale con DRM del De Brevitate Vitae di Seneca: lo stesso testo ottenuto dal Forzetta con lo sforzo di copisti e amanuensi. È il 2715: non so se i miei discendenti potranno leggere la mia copia del De Brevitate Vitae.
È il 1981: qualcuno ha comprato una copia di Donkey Kong per Atari VCS, la più famosa console di seconda generazione, e l’ha giocato fino a stancarsene. È il 2025: in un anelito di nostalgia costui riaccende l’Atari (o una sua riproduzione moderna come il 2600+), per riprendere quella partita. È ancora il 2025: lo stesso soggetto ha comprato Donkey Kong: Bananza, titolo Nintendo esclusivo per Nintendo Switch 2, pupilla della nona generazione. È il 2069: volendo potrà ancora giocare al primo Donkey Kong, ma senza scaricare le patch del day one e avere accesso a server non più attivi non potrà proseguire quella partita a Bananza.
Riservatezza, Integrità, Confidenzialità: la triade RIA, o CIA in Inglese, è sempre stata il pilastro su cui si è poggiata la trasmissione dei dati nello spazio e nel tempo, un abracadabra (secondo un noto paraetimo “Io creo con la parola”, incantesimo antesignano delle enunciazioni performative) reso possibile anche dalla possibilità di replicare informazioni e fruirne. In un mondo dove la copia diventa qualcosa da cui proteggersi, la trasmissione del dato stessa è a rischio.
Il codice e la trasmissione interrotta
Il 4 febbraio del 2014, all’alba dell’attentato alla sede di Charlie Hebdo, Panini Comics, editore del celebre settimanale Topolino, avrebbe dovuto uscire con una cover evento, feticcio altamente collezionabile ma dal valore storico.
Gli abbonati alla rivista in digitale, già dal pomeriggio del 3 febbraio, poterono ottenerne una copia. Caruccia, innocente, con dei bambini con una matita in mano. Il 4 febbraio le copie in edicola ebbero un’immagine (goffamente) rimodellata da una delle storie pubblicate (il “Pippo Reporter”) e gli utenti in telematico, invece, una brutta sorpresa: la loro libreria digitale era stata svuotata della cover “storica”, sostituita surrettiziamente in una operazione tra il gaslight e la riscrittura Orwelliana del MinVer di 1984 con la cover apparsa in edicola.
In quel momento, la “libreria virtuale” ha perso di integrità: se un testo conservato scompare col suo contenuto, l’informazione-numero 3089 ha perso il dato “copertina legata alla strage di Charlie Hebdo”. E ricostruire il dato perso, in un mondo in cui questo è destinato alla distruzione da remoto, come i celebri messaggi della serie televisiva Mission: Impossible (o della loro giocosa parodia ne L’Ispettore Gadget), diviene impossibile.
Non è oziosa lamentela da veterocollezionista; diversi “codici” sono stati salvati esattamente così: dalle loro copie. Diversi episodi del serial televisivo Doctor Who, specialmente appartenenti alle prime stagioni degli anni ’60, sono ormai irrimediabilmente persi, e molti di quelli ritenuti perduti sono riapparsi nelle consunte cassette di collezionisti e amatori armati di videoregistratori VHS e Betamax, e molti nastri logori sono stati “reintegrati” di scene ormai illeggibili dalle loro copie. Keep Circulating the Tapes, “non smettere mai di trasmettere copie”, è sia un invito che uno dei nuovi tropi censiti da una pagina dedicata allo scopo: TV Tropes.
Tropo incarnato, non a caso, dall’attivista, produttrice e archivista Marion Stokes che, grazie ad una attività ultratrentennale (1977-2012), divisa tra nastri Betamax e VHS, ha di fatto preservato per le generazioni future decenni di trasmissioni ed eventi mediatici, non a caso incorporati in Internet Archive, progetto nato per preservare il sapere e la conoscenza umana.
Non si tratta di tropo così moderno: è così che furono preservate le basi stesse del canone occidentale.
Come ogni buon archivista saprà, e come si sintetizza nel poco spazio concesso, copisti e amanuensi hanno conservato il sapere rendendo possibile ricostruire testi ormai datati nel tempo mediante la filologia, la scienza dell’errore che consente di ricostruire un albero genealogico di copie, identificando parti corrotte del testo e reincorporandole partendo da apografi e antigrafi, copie e copie di copie, creando una “genealogia dell’errore”.
Se un testo ha delle lacune, esse potranno essere colmate ricorrendo a copie ulteriori dello stesso, ovvero all’edizione più prossima all’originale. Nei casi più disperati, i novelli Adso da Melk potranno agire nel freddo di uno scriptorium col pollice dolente, nel tentativo di identificare pochi lacunosi lacerti, macerie di una biblioteca in rovina e brandelli di pagine, da cui identificare capitoli che identificheranno libri da cui cercare copie, per ricostruire un perduto codice.
In termini moderni, laddove l’integrità è stata danneggiata, se non obliterata, la disponibilità di copie ulteriori consente di ripristinarla.
Il dato diventa “meme”, non già nell’esasperato senso moderno di virus dell’intelletto, agente eziologico del brainrot come innesto permanente del pensiero (al pari di una “canzoncina che non va più via dalla testa”), ma come unità base e strutturale del codice genetico di un testo: non a caso, un codice. Come il codice genetico umano trae dalla sua struttura a doppio filamento la sua resistenza a mutazioni che ne compromettano l’integrità, il “diritto/dovere/bisogno” di copia conferiscono all’informazione la capacità, sia pur limitata, di mantenersi integra.
Finché copiare diventa difficile.
Dal Tecnofeudalesimo a Stop Killing Games
Negli scritti dell’economista Yannis Varoufakis appare una parola, abusata sovente negli ambienti del complotto (e come tale, privata del suo primigenio significato): tecnofeudalesimo.
Essa descrive l’evoluzione suprema, e in un certo senso parricida, del capitalismo: l’epoca in cui il controllo dell’informazione stessa è passato di mano alle Big Tech, il consumatore diventa tecnoservo della gleba ed esso non ha più signorie, ma licenze d’uso.
Se, nel piccolo, Panini può decidere che concedere un numero di Topolino dedicato a Charlie Hebdo è stato un errore, e “revocarlo” nella libreria digitale dei singoli utenti ad nutum, Steam, itch.io, GoG, e altri operatori del settore delle librerie di videogames disponibili online, possono delistare i giochi. Di fatto, cancellandoli dagli scaffali virtuali e impedendone acquisto e download. N.B, questo può avvenire per diversi motivi, di cui alcuni di eticità inoppugnabile: si possono avere titoli delistati perché “abbandonati” dai loro creatori, perché sostituiti da nuove edizioni o perché improvvisamente, vedasi il recente caso di itch.io, la compagnia è stata messa di fronte alla necessità di rivedere le policy etiche e morali, scegliendo la via del retcon di fatto, retroattiva modifica della realtà con l’effetto di cancellare pezzi di una libreria virtuale divenuta scomoda. Resta comunque intatto il problema aperto.
Se il digitale piange, il fisico non ride: per gioco e avventura qualcuno ha provato a censire le condizioni di uso di svariati editori, scoprendo una clausola di dubbia giustiziabilità. Chi ha comprato un videogame di diversi operatori del settore, come Bethesda, Ubisoft, SEGA, Square-Enix e Capcom, potrà scoprire di aver sottoscritto una policy che lo impegna a distruggere i supporti fisici di giochi non più supportati. Un vero incubo per molti collezionisti: la stessa Bethesda vendette al lancio uno dei suoi più famosi giochi di ruolo online (dipendenti quindi dai loro server per funzionare), Fallout 76, in una edizione di extralusso dal valore di 200 Euro al lancio, salito, come oggetto di collezionismo, ad un prezzo dai 600 ai 1000 euro. Valore ovviamente dipendente dall’integrità del feticcio collezionabile di cui si richiede l’obliterazione.
Si immagini ora un mondo non capitalista, ma tecnofeudale in cui Max Brod fosse riuscito a salvare i testi di Franz Kafka, che egli voleva distrutti dopo la sua morte, tra cui Il Processo, ma qualcun altro avesse deciso che invece il rogo era giusto e necessario e avesse avuto il potere di effettuare quel rogo. Distruggendo ogni copia dei testi di Kafka, a prescindere dal loro valore economico e sentimentale, in modo rapido, assoluto e impedendone il recupero dell’integrità.
Siamo nel tecnofeudalesimo: il dato non è venduto, ma concesso, e quindi revocabile. E il dato può essere dato e tolto, oppure menomato dell’integrità o dell’accessibilità. Stop Killing Games è proprio un appello rivolto ad uno dei principali signori del Nuovo Feudo, i produttori di opere dell’intelletto e dell’intrattenimento come i videogiochi, perché loro smettano di usare la signoria concessagli dal sistema Tecnofeudale per mutilare a scelta Integrità o Accessibilità del dato, o entrambe le cose contemporaneamente.
Si torni ora all’introduzione (e si perdoni l’abuso dello scroller): il Tecnofeudalesimo ha di fatto abolito, per una lunga serie di prodotti intellettuali, due elementi della Triade RIA e reso impossibili gli elementari meccanismi di correzione che li terrebbero vivi. In altri termini, un videogame reso inavviabile e inaccessibile da un controllo di sicurezza all’avvio è integro ma non accessibile, un gioco privato di patch e contenuti successivi al lancio è accessibile ma non integro.
Si può offrire un esempio pratico che con un solo titolo ripercorra l’intera premessa: nel 1998 era possibile giocare Tombi!, killer app (amatissimo gioco che spinge le vendite di una console) della PlayStation di prima generazione. Nel 2025 è possibile farlo nello stesso modo, inserendo l’iconico CD dallo sfondo nero nella console, e sarà possibile farlo in futuro.
Nel 2024, LGR ha lanciato una nuova riedizione per console moderne ma, senza la corposa correzione del Day One, il gioco non è abbastanza integro da essere giocato. Senza un particolare aggiornamento per la console Switch 2, il gioco è integro ma non accessibile (una singola linea di codice rende impossibile alla console fornire output video): versioni precedenti del firmware “rompono la compatibilità”: il gamer-archivista del futuro dovrà porsi il problema di collezionare ambo le patch.
Un videogame del quale non è più possibile scaricare patch di sicurezza, aggiornamenti e “patch di qualità” per correggere errori e introdurre nuovi contenuti, e del quale non è possibile o è scarsamente possibile farlo, non è più integro. Un videogame del quale ti viene chiesta la distruzione fisica dei media in tuo possesso ha cessato di essere integro e accessibile, e la riservatezza diviene parva consolazione.
Parimenti, questo è il destino di altri prodotti dell’intrattenimento: la recente chiusura dell’e-shop Dark Horse (editore di fumetti americano) è stata salutata da un sobrio messaggio che invita a “scaricare i fumetti nella propria app” (dalla quale, come per l’app Abbonamenti.it/Panini citata, non esiste una modalità di backup integrata) perché “tecnicamente tu non possiedi i nostri libri, ma solo il diritto di leggerli su un dispositivo autorizzato”, nonché da interventi di fan inclini a cercare modi alternativi per recuperare quei testi, consci della complessità e potenziale (eufemismo) illegittimità degli stessi.
Per non parlare della recente quanto sconcertante sorpresa (al momento della stesura) patita dalla scrittrice horror Mae Rossi che, usando Google Drive come archivio per i suoi scritti e materiali, ha scoperto di aver perso l’accesso ai suoi ultimi manoscritti e liste di libri e film consultati, estendendo la gleba tecnofeudale dai prodotti dell’intrattenimento che detieni a quelli che vorresti creare o anche solo alle liste di ciò che vorresti fruire.
Il mondo senza amanuensi
Nell’era tecnofeudale, l’utente vive in un mondo dove la trasmissione del codice è persino più difficile che nell’era feudale primigenia: se un numero incalcolabile di testi è stato salvato dal pollice dolente degli amanuensi, oggi il tecnoamanuense del tecnofeudo non è più un chierico amato e riverito, ma un ribelle, un netrunner sul sottile filo tra lecito e illecito guardato con sospetto dalla feudo-corporazione.
Dal punto di vista dell’archivista 2.0, il tecnofeudalesimo è simile, infatti, alla Night City delle suggestioni Cyberpunk di cui si è parlato in queste pagine: un mondo dove il mezzo adeguato di protezione diventa mezzo per spezzare il diritto alla copia, che diventa diritto alla preservazione.
Ancora una volta, la ribellione parte dal gamer e dal nerd, portatore di interessi di nicchia, “baro e resistente digitale” (si consenta, ancora, la vanità di una necessaria autocitazione) che, nel peccare contro il suo moderno Sire e il moderno Monastero, cerca di aprire una discussione per salvare una percentuale di prodotti culturali del mondo digitale quantificata intorno all’87% della produzione videoludica (esclusa la falcidia di webcomic e siti web).
Ed è una prosecuzione di Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984), la celebre sentenza che stabilì che il “diritto a registrare” fosse conseguenza del “fair use”, potenziale pietra angolare per traghettare il tecnoamanuense, nuovo resistente digitale (e il suo guerrilla archiving, archivismo eversivo e militante che ridà potere al fruitore), dal passato al futuro.
C’è chi compra edizioni stampate di webcomic (fumetti nati per la divulgazione online), nel tentativo di trasmetterne ai posteri almeno una parte, e c’è chi cerca di ritrovarne le pagine come un moderno Adso Da Melk. C’è chi rifiuta di cancellare o distruggere i media dei propri videogames, e c’è chi censisce infiniti bootleg (“tarocchi”, copie modificate dello stesso gioco), come il celebre Lode Runner trasformato in Fugone e Remigio, garantendo che gli archivisti del futuro potranno, nel caso, ricostruirlo partendo da copie taroccate con copertine e storie ingenue.
C’è chi ritiene che, nel mondo senza amanuensi, la rosa primigenia esiste solo nel nome, possediamo soltanto nudi nomi. E c’è chi pensa a come mettere in salvo il concetto alla base di quel nome prima che il giardino diventi deserto.
PAROLE CHIAVE: amanuensi / archivio / canone / CIA / copia / integrità / Marion Stokes / Stop Killing Games / tecnofeudalesimo / trasmissione
Tutti i contenuti presenti in questa rivista sono riservati. La riproduzione è vietata salvo esplicita richiesta e approvazione da parte dell’editore Digitalaw Srl.
Le foto sono di proprietà di Marcello Moscara e sono coperte dal diritto d’autore.