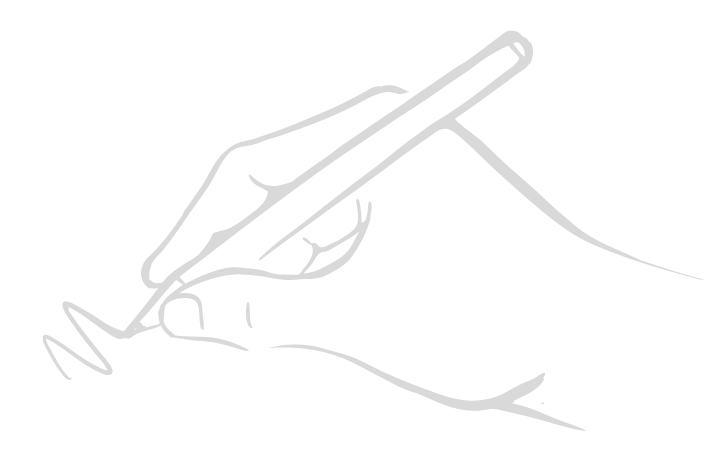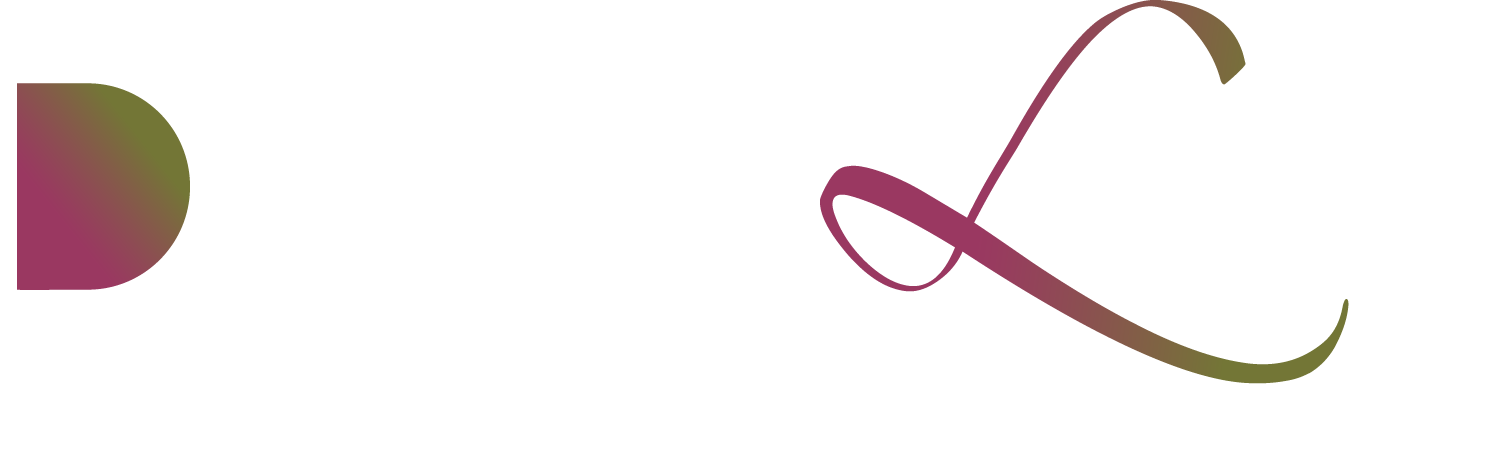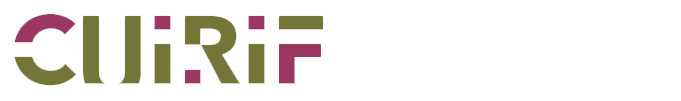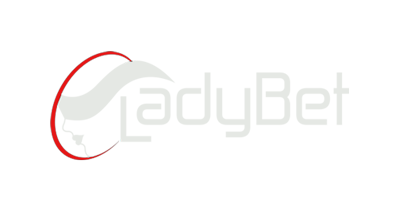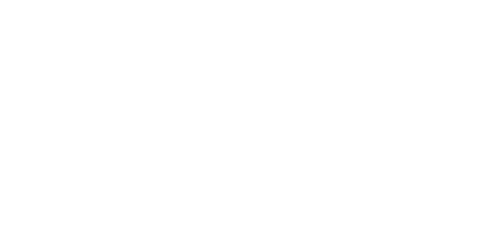Abstract
L’entropia nel mondo delle comunicazioni può essere moderata dal Metodo Didascalico, che è teleologicamente finalizzato a chiarire e a spiegare definizioni e concetti. Grazie ad esso, si può migliorare la qualità dei metadati. Il linguaggio soverchia il contenuto e anche i media, rappresenta esso stesso il messaggio, per cui il livello qualitativo della lingua è il discrimine fra l’alto e il basso, fra i contenuti nobili e quelli ignobili.
La rivincita del Metodo Didascalico
Per decenni l’aggettivo didascalico ha rappresentato un limite, una palla al piede del concetto sul quale si concionasse. Attribuire a qualcuno o a qualcosa l’epiteto di didascalico equivaleva ad una stroncatura, ad un’offesa, in ogni caso rappresentava un giudizio limitativo e degradante, relativo alla riduzione delle pretese di una qualsivoglia esposizione concettuale tendente all’ammaestramento, all’asfittica visione scolastica, alla monotonia.
Eppure, con l’incedere dell’entropia nel mondo delle comunicazioni, con l’esplosione degli enti che trasmettono messaggi, dei canali social, dell’interconnessione, tutto ciò che è di impedimento alla chiarezza e all’univocità del messaggio rappresenta un fattore di rischio e di confusione, d’incertezza e d’inquietudine.
In un contesto siffatto, il Metodo Didascalico, finalizzato teleologicamente alla spiegazione, al commento chiarificatore, all’insegnamento, all’indottrinamento, riemerge come una forza salvifica che chiarisce angoli e prospettive caduti nel cono d’ombra dell’oscurità concettuale.
I metadati
Il termine metadato non attiene alla metafisica del dato, bensì all’insieme delle informazioni relative ai dati, laddove per dati si intende risorse, prodotti, entità, luoghi, istituzioni, opere (concrete o astratte che siano).
I metadati aiutano a descrivere, a identificare, a fornire coordinate strutturali nonché una panoramica delle caratteristiche, a dettagliare informazioni essenziali o accessorie del dato/risorsa. Cosicché, i metadati assolvono a differenti scopi: dalla semplificazione al miglioramento della ricerca o dell’analisi, dalla circoscrizione del fenomeno alla localizzazione dello stesso, dalle relazioni esistenti fra i fenomeni all’identificazione delle risorse o alla comparazione competitiva/analogica fra i dati.
Grazie ai metadati, ciascun dato diviene più e meglio conoscibile, più trasparente, meno respingente o misterioso, più diffondibile, più visibile, più monitorabile, in definitiva più accessibile e friendly.
Ne consegue quanto siano cruciali l’esistenza e la qualità dei metadati nel mondo analogico e digitale nel quale siamo immersi. E, a cascata, appare lampante quanto sia di ausilio il metodo didascalico che, come un demiurgo invisibile, crea, definisce e legifera l’universo che ci circonda (e del quale siamo atomi).
La qualità del linguaggio soverchia la qualità dei contenuti
Fatte queste opportune premesse, per quanto essenziali, viene da domandarsi quale sia l’ingrediente cardine – in un mondo oberato dalla sovrabbondanza di contenuti – che magnetizzi un’attenzione sempre più difficile da ottenere e ancor più da mantenere. Come sia possibile, detto in altri termini, ottenere fiducia, raggiungere e far raggiungere un livello di comprensione all’interlocutore, all’uditore, al ricevente, al destinatario.
Ad un’analisi superficiale, sembrerebbe scontato che la variabile decisiva sia rappresentata dalla qualità dei contenuti. Non mancano correnti, sebbene minoritarie, che reputano, al contrario, che la proprietà di linguaggio debba essere l’ingrediente alchemico capace di esercitare un potere di seduzione sul target. Altri ancora sono estimatori di una teoria mista, dove linguaggio e contenuti si fondano e contribuiscano ciascuno al raggiungimento dei propri scopi.
Il linguaggio è la forma che assumono le idee, il vestito con il quale si presentano in società. E, se è sempre stato vero che nel campo del diritto “la forma è sostanza”, anche per tutti gli altri campi che siano suscettibili di essere intellegibili e di essere percepiti e comunicati, il vestito che indossano le idee e i dati finisce per soverchiare il corpo che si orna con simili vestimenti.
Siamo la società dell’immagine e, in quanto tale, la società dell’apparire, quella dove all’apparenza si attribuisce un giudizio che si estende alla sostanza; un giudizio, si badi, unilaterale, perché quello estetico coinvolge inesorabilmente quello etico e contenutistico, ma non è vero il contrario: nessuno pensa di poter attribuire rilevanza, peso e valore a tutto ciò che si presenta come rifiuto, come scarto, come res nullius, come sottoprodotto da destinare alla discarica.
Il corpo, la sostanza, il contenuto vengono degradati dalle dinamiche sociali alla categoria di manichino, utile sì, ma nella misura in cui sostengano e rendano meglio visibile il vestito.
Il linguaggio diviene, in una tale visione estetica, l’ornamento necessario, il gioiello che abbellisce il décolleté, il polso, la mano, la capigliatura, l’orecchio, facendo dimenticare la parte del corpo ornata e facendo ricordare la luminosità, la preziosità e la brillantezza dell’ornamento.
Contenuti eccellenti possono apparire inutili o risibili se non vengono adeguatamente abbigliati, comunicati, agghindati, veicolati: fraseggio articolato e verbosità dell’aggettivazione, oscurità terminologica e strutture ridondanti, tono inappropriato al contesto o aulicità innaturale, prolissità e ripetitività, sono solo alcuni epifenomeni suscettibili di mascherare o addirittura di rovinare la coerenza intrinseca del contenuto, trasformando un messaggio prezioso in rumore di fondo, in materia non afferrabile, in metadato inutile, in sostanza dimenticabile.
Agli antipodi, la chiarezza del linguaggio, l’accessibilità e l’accuratezza, possono rendere qualunque contenuto memorabile, leggibile, beverino, leggero, scorrevole e immediato, accrescendo le probabilità che l’audience innanzitutto veda, che legga, che possibilmente comprenda, che sperabilmente ricordi e magari anche agisca. La cura del linguaggio, ci si sente ripetere a più voci, non può né deve essere separata dalla qualità dei contenuti, piuttosto occorre che forma e contenuto, che dato e metadato, si integrino e fondano assieme in una pietanza riuscita, tanto gradevole quanto gustosa. Contenuti validi che vengano presentati con un linguaggio ostico o ambiguo, rischiano di interporre uno schermo fra il trasmittente e il ricevente che ostacola il dialogo, la comunicazione e, dunque, la comprensione. Contenuti meno importanti, poco altisonanti e scarsamente ambiziosi, ma ammantati di precisione e di stile, ottengono sovente impatti superiori a quanto meriterebbero.
E dunque? Conta più la carrozzeria del motore? Certamente sì. Senza motore non ci si muove, ma senza ruote e sedili non è pensabile il movimento.
Che si debba privilegiare la costruzione attenta dei metadati come porta di accesso al paradiso dei dati è una realtà inconfutabile dalla quale non si prescinde. La si può ignorare, ma solo se si resta in un mondo invischiato nel passatismo di chi rifugga aprioristicamente l’allineamento all’evoluzione del contesto.
Il linguaggio è il messaggio
Gli ultimi 60 anni sono stati segnati dalle teorie di Marshall McLuhan, universalmente sintetizzate nello slogan: “il medium è il messaggio”. Il filosofo canadese spiegò: “Il contenuto o messaggio di un qualsiasi medium ha tanta importanza quanta ne ha la stampigliatura sulla cassa d’imballaggio di una bomba atomica. (…) Affermando che il medium è il messaggio, piuttosto che il contenuto, io non voglio affermare che il contenuto non giochi nessun ruolo, ma piuttosto che il suo ruolo è di natura subordinata”.
Il medium è ogni singolo mezzo di comunicazione e di informazione, cioè il veicolo di ciascun messaggio che McLuhan studia in quanto tale, non sulla base dei contenuti che i media veicolano, bensì in base ai criteri strutturali con cui organizzano la comunicazione.
Il passo successivo, vorrei dire contemporaneo, è nella subordinazione anche del medium, oltre che del contenuto. Il mezzo di trasmissione ha perduto il fascino e la magia che portava con sé, come lo hanno perduto il circo, la radio e la televisione, fino allo smartphone che oggi reputiamo oltremodo indispensabile, ma che dopodomani sarà archeologia quando un sistema biomedico integrato ci consentirà di interloquire con l’AI direttamente pensando i prompt, di comunicare con chiunque tramite auricolari fissi e microfoni installati nei denti, di guardare ogni immagine/filmato direttamente negli occhiali. Il medium in quanto tale è al tramonto.
Non è così per il linguaggio, che informa di sé qualsivoglia contenuto e declina qualsiasi metadato con approcci modulari e modulabili, flessibili ed estensibili, ostensibili o criptici. Lavorare sulla qualità del linguaggio non è più prerogativa delle classi docenti, di quelle manageriali, del marketing per il mondo globalizzato dell’economia di mercato. No. La qualità del linguaggio è l’attrattore prìncipe, è il seduttore in chief, è la misura di valore ed è il carato – vale a dire la misura di purezza – con il quale attribuire peso e consistenza a tutto.
Il vino è una spremuta d’uva fermentata, ma in quanto tale ha un valore venale ridicolmente basso. È il linguaggio che ne fa filosofia: dal terroir alla nobiltà del vitigno, dal blasone della cantina all’arte dell’affinamento. Di talché il vino non si beve più, ma è “di pronta beva”, è ostico, chiuso, oscuro e misterioso, pronto ad aprirsi solo dopo adeguata e iniziatica ossigenazione che ne restituisca il respiro, il soffio vitale.
Lo stesso è a dirsi per i metalli preziosi, per le stoffe, per i profumi, per le automobili, per le pietre preziose, per i marmi, le tele dipinte, le sculture, le meraviglie della natura e quelle della tecnica. È il linguaggio che ne fa poesia, che ne elabora la considerazione, che ne costruisce reputazione, che ne forgia autorevolezza, che ne instaura il regno, che ne imbastisce mitologia.
Il linguaggio è il messaggio, lasciate che le parole rivestano il mondo, ne inventino di infiniti, che facciano narrativa e letteratura, che sfavillino sui metadati, che dòminino sui dati, che trasfigurino la lotta di classe non più fra chi detenga i mezzi di produzione e chi possegga la forza lavoro, quanto piuttosto fra chi è in grado di affabulare e chi sia succube dell’affabulazione, fra l’imbonitore e l’imbonito, fra l’alchimista iniziato e il credulone che non ha mezzi per difendersi dalla misterica di Giove Pluvio.
La proprietà di linguaggio si vende, ha valore e non lascia nessuno a digiuno. Fulmini, grandine e pioggia di Giove possono cancellare i raccolti e rendere vana la coltivazione della terra, provocando carestie. Il linguaggio è prioritario e principe, i contenuti verranno. La locuzione latina “rem tene, verba sequentur” (possiedi l’argomento, le parole verranno da sé) dev’essere ribaltata in “verba tene, res sequentur” (possiedi le parole, affinché i contenuti vengano da sé).
Questo articolo è 100% NAI (Not Artificial Intelligence)
PAROLE CHIAVE: comunicazione / contenuti / dati / linguaggio / medium / messaggio / metadati / metodo didascalico / qualità
Tutti i contenuti presenti in questa rivista sono riservati. La riproduzione è vietata salvo esplicita richiesta e approvazione da parte dell’editore Digitalaw Srl.
Le foto sono di proprietà di Marcello Moscara e sono coperte dal diritto d’autore.